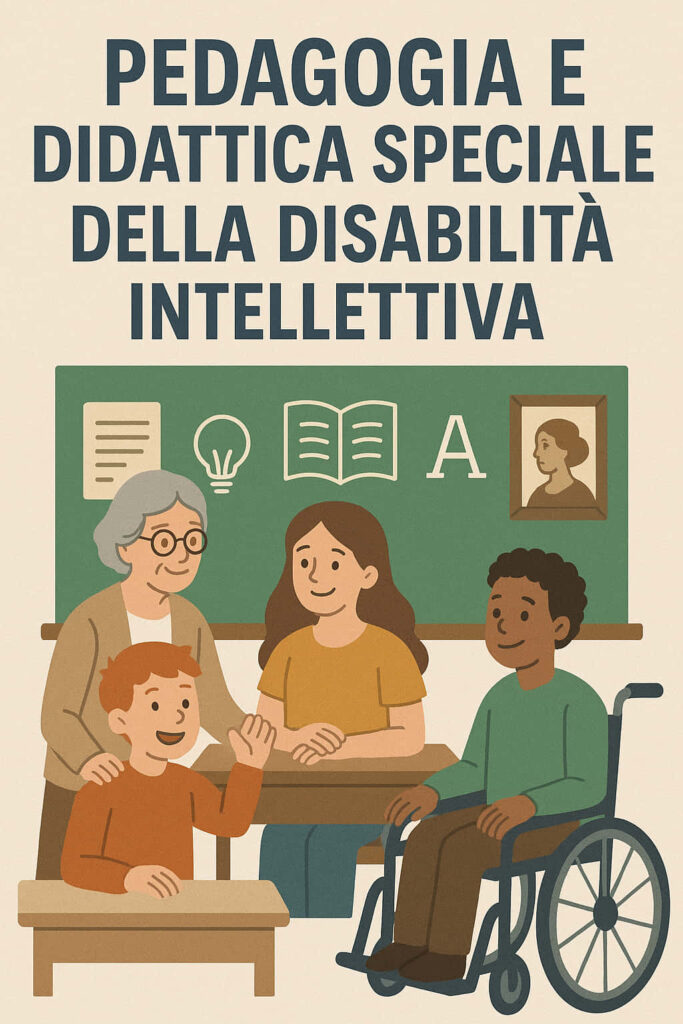Deficit, disabilità, handicap e normalità
Nell’ambito della pedagogia speciale, termini come deficit, disabilità, handicap, patologia e normalità rappresentano tappe fondamentali nell’evoluzione dei modelli educativi e sociali.
Il deficit indica una perdita o menomazione di natura organica, funzionale o psicologica che può compromettere lo sviluppo individuale. Tuttavia, la prospettiva pedagogica sottolinea che il deficit non esaurisce l’identità della persona, ma rappresenta solo una dimensione della sua condizione. Si tratta, dunque, di una differenza funzionale e non di una riduzione dell’individuo alla sua mancanza.
Il termine disabilità, introdotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità negli anni Ottanta, riguarda le limitazioni nell’attività e nella partecipazione che derivano dall’interazione tra deficit individuali e barriere ambientali. È in questo contesto che nasce l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), che sostituisce la precedente terminologia legata all’“handicap”.
L’handicap, infatti, non descrive la condizione della persona ma l’impatto che la disabilità ha nel contesto sociale, familiare e istituzionale. Esso va inteso come distanza tra le potenzialità dell’individuo e le risposte che l’ambiente offre, evidenziando come la disabilità sia il risultato di un’interazione tra caratteristiche personali e barriere esterne.
Il concetto di patologia, invece, affonda le sue radici nel linguaggio medico, legato al DSM e alle diagnosi cliniche. In passato, nella prospettiva della pedagogia curativa o emendativa, l’attenzione era rivolta al “problema” da correggere piuttosto che alla persona. Oggi, questo approccio viene problematizzato perché rischia di confinare la diversità nell’ambito della malattia, riducendo l’intervento educativo a terapia. L’azione pedagogica deve invece rimanere educativa e didattica, non medica o farmacologica.
La normalità, intesa come costrutto statistico e astratto, non è mai riscontrabile in modo assoluto. Ogni individuo porta con sé elementi di diversità, che diventano parte integrante della sua identità. La pedagogia speciale mette in guardia dal rischio della “normalizzazione”, cioè l’idea che la persona con disabilità debba necessariamente colmare un divario con i normodotati per essere accettata. L’obiettivo è invece riconoscere la diversità come valore e diritto, in linea con l’articolo 3 della Costituzione italiana.
Bisogni Educativi Speciali (BES)
L’evoluzione del linguaggio pedagogico ha portato all’introduzione della categoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Essa non riguarda solo gli alunni con disabilità certificata, ma anche chi presenta difficoltà di apprendimento, svantaggi sociali o culturali, come nel caso degli studenti stranieri.
Gli strumenti operativi principali sono il PEI (Piano Educativo Individualizzato), destinato agli alunni con disabilità certificata, e il PDP (Piano Didattico Personalizzato), che può essere adottato per studenti con DSA o altre difficoltà temporanee. L’approccio attuale mira a superare le etichette, preferendo la personalizzazione educativa e la flessibilità metodologica.
Dal concetto di inserimento all’inclusione
L’evoluzione della scuola italiana riflette un percorso che va dal semplice inserimento all’integrazione e, infine, all’inclusione.
Inserimento: introdotto con la legge 118 del 1971, prevedeva la collocazione degli alunni con disabilità nelle scuole ordinarie, senza un reale adattamento dei contesti educativi. Spesso veniva definito “inserimento selvaggio”, perché insegnanti e scuole non erano adeguatamente preparati.
Integrazione: sancita dalla legge 517 del 1977 e consolidata con la legge 104 del 1992, superò le classi speciali introducendo il diritto alla frequenza nella scuola comune e la figura dell’insegnante di sostegno. Tuttavia, il modello rimaneva compensatorio, focalizzato sul colmare le carenze dell’individuo.
Inclusione: rappresenta il cambio di paradigma più recente. Il sistema educativo non si limita più ad adattare l’individuo, ma ripensa sé stesso per accogliere e valorizzare le differenze. La dichiarazione di Salamanca del 1994 e la classificazione ICF del 2001 hanno contribuito a consolidare un approccio bio-psico-sociale, che considera la disabilità come il risultato di un’interazione negativa tra persona e ambiente.
Con la legge 170 del 2010 e la direttiva del 2012, il concetto di inclusione si è ulteriormente ampliato, estendendosi a tutti gli studenti con BES, compresi coloro che affrontano svantaggi linguistici, culturali o socio-economici.
Nuova terminologia e prospettive attuali
Un ulteriore passo avanti si è avuto con il decreto legislativo n. 62 del 2024, che ha aggiornato la terminologia ufficiale: termini come handicap o minorato sono stati sostituiti con persona con disabilità o persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Questo cambiamento linguistico riflette un mutamento culturale più ampio, volto a garantire rispetto e dignità.
L’inclusione non è un traguardo statico, ma un processo dinamico che richiede costante aggiornamento, formazione degli insegnanti e collaborazione tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari.
Evoluzione normativa della scuola inclusiva in Italia
Dall’inserimento all’integrazione
L’evoluzione del sistema scolastico italiano in materia di inclusione ha seguito un percorso progressivo, che può essere ricondotto a tre tappe fondamentali: inserimento, integrazione e inclusione.
Il primo passo significativo è rappresentato dalla legge 118 del 1971, che stabilì l’obbligo di inserire gli alunni con disabilità nelle classi ordinarie della scuola pubblica. Questa norma segnò il superamento del modello segregante delle scuole speciali e delle classi differenziali, pur senza abolirle del tutto. Tuttavia, il contesto scolastico rimase sostanzialmente immutato: l’alunno con disabilità veniva collocato in un ambiente comune, ma senza un reale adattamento pedagogico. Per questo motivo si parlò spesso di “inserimento selvaggio”, poiché docenti e istituzioni non erano preparati a garantire un sostegno educativo mirato. L’assistenza era perlopiù di tipo igienico-sanitario, con poca attenzione all’apprendimento.
Un passo avanti decisivo si ebbe con la legge 517 del 1977, che abolì le classi differenziali e sancì il diritto degli studenti con disabilità a frequentare la scuola comune. Per la prima volta fu introdotta la figura dell’insegnante di sostegno, con il compito di facilitare i processi di apprendimento e di inclusione. L’integrazione, però, manteneva una logica compensatoria: il problema veniva ancora visto come deficit individuale, da correggere attraverso strumenti speciali.
La fase successiva fu segnata dalla legge 104 del 1992, considerata una pietra miliare per i diritti delle persone con disabilità. Questa norma ampliò il quadro di tutele, includendo l’assistenza, l’integrazione sociale e l’istruzione. Introdusse strumenti fondamentali come il Piano Educativo Individualizzato (PEI), condiviso da docenti curricolari e insegnanti di sostegno, a garanzia di un percorso educativo personalizzato.
Verso il paradigma dell’inclusione
Negli anni successivi, la prospettiva si ampliò ulteriormente. A livello internazionale, la Dichiarazione di Salamanca del 1994 rappresentò un punto di svolta, affermando il principio che le scuole devono essere ripensate per accogliere tutti gli alunni, valorizzando la diversità come risorsa e non come limite.
In ambito scientifico, la Classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell’OMS, introdotta nel 2001, segnò il passaggio da un approccio medico al modello bio-psico-sociale. Secondo questa prospettiva, la disabilità non è più un problema della persona in sé, ma il risultato dell’interazione tra caratteristiche individuali e barriere sociali, culturali o ambientali.
In Italia, un ulteriore ampliamento del concetto di inclusione è avvenuto con la legge 170 del 2010 e con la direttiva ministeriale del 2012, che hanno esteso il diritto a una didattica personalizzata anche agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e a coloro che vivono condizioni di svantaggio linguistico, culturale o socio-economico. In questo modo, il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) ha assunto un ruolo centrale, includendo non solo le disabilità certificate ma anche tutte le situazioni che richiedono adattamenti educativi temporanei o permanenti.
Un cambiamento di paradigma
Questo percorso legislativo testimonia il passaggio da una visione centrata sul deficit individuale a un modello inclusivo, in cui è il sistema scolastico ad adattarsi alla diversità degli studenti. L’inclusione non è più considerata un atto di concessione, ma un diritto di cittadinanza educativa.
L’evoluzione normativa ha dunque trasformato l’idea di scuola: da luogo che accoglie passivamente la diversità, a comunità educativa che la valorizza come risorsa collettiva.
Il linguaggio come strumento di inclusione
La nuova terminologia normativa
Uno degli aspetti più significativi dell’evoluzione della pedagogia speciale riguarda l’uso del linguaggio. Le parole non sono mai neutre: possono veicolare rispetto e inclusione oppure, al contrario, stigmatizzare ed escludere.
In questa direzione si inserisce il decreto legislativo n. 62 del 2024, che ha aggiornato la terminologia ufficiale in materia di disabilità. Il provvedimento stabilisce la sostituzione di termini considerati superati o potenzialmente discriminatori.
Espressioni come handicap, portatore di handicap o persona handicappata vengono abrogate, sostituite da persona con disabilità.
L’espressione disabile grave lascia spazio alla definizione persona con necessità di sostegno intensivo.
Le diciture in situazione di gravità o condizione grave sono state riformulate in necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Questo aggiornamento linguistico non è soltanto un cambiamento formale, ma rappresenta un passo culturale importante. Le nuove espressioni pongono l’accento sulla persona prima che sulla condizione, in linea con i principi di dignità e rispetto dei diritti umani.
Dal lessico della segregazione al linguaggio inclusivo
Un confronto con le normative del passato evidenzia quanto sia cambiata la sensibilità sociale. Termini come minorato o menomato, ampiamente utilizzati nella legislazione degli anni Settanta, oggi appaiono anacronistici e stigmatizzanti. L’evoluzione del linguaggio riflette l’evoluzione della cultura pedagogica: dall’idea di “correggere un deficit” a quella di riconoscere e valorizzare le differenze individuali.
Il linguaggio inclusivo diventa così un mezzo educativo e culturale. Non si limita a descrivere una condizione, ma contribuisce a costruire un immaginario collettivo più rispettoso, in cui la diversità non è percepita come anomalia bensì come parte integrante della società.
Implicazioni pratiche nella scuola
L’adozione di una terminologia aggiornata ha anche conseguenze operative per il mondo scolastico. Nei documenti ufficiali come PEI e PDP, così come nelle comunicazioni interne (verbali dei consigli di classe, relazioni, moduli), è necessario uniformarsi al nuovo linguaggio.
Ciò comporta una maggiore attenzione nella redazione degli atti e nella comunicazione con famiglie, alunni e colleghi. Le parole, infatti, possono influenzare la percezione del ruolo dell’alunno con disabilità all’interno del gruppo classe. Un linguaggio rispettoso e non stigmatizzante diventa quindi un elemento essenziale del processo inclusivo.

Disponibile il nuovo volume!
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Appunti pratici per il percorso TFA Sostegno
Il libro raccoglie e rielabora in forma di appunti personali i principali argomenti affrontati durante lo studio del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, fornendo una panoramica chiara e organizzata delle tematiche trattate.
Non si tratta di dispense ufficiali, ma di un supporto pratico allo studio, pensato per chi vuole avere una sintesi ragionata e facilmente consultabile.
Riflessioni sull’esperienza scolastica e inclusiva
Competenze sviluppate al di fuori della scuola
Molti studenti, nel corso del loro percorso formativo, hanno sperimentato limiti strutturali del sistema scolastico che li hanno portati a sviluppare competenze e valori al di fuori delle aule. Tra queste emergono con forza qualità come resilienza, empatia, autonomia e fiducia in sé stessi.
La resilienza, intesa come capacità di rialzarsi di fronte alle difficoltà, viene spesso citata come un’abilità appresa nonostante, e a volte proprio in assenza, di un sostegno scolastico adeguato. L’empatia, la capacità di comprendere e immedesimarsi nell’altro, è stata riconosciuta come uno strumento fondamentale per costruire relazioni significative sia a scuola che nella vita quotidiana.
Queste testimonianze mettono in luce un aspetto cruciale: l’apprendimento non si esaurisce tra i banchi di scuola. Spesso le situazioni di disagio spingono gli studenti a sviluppare strategie personali di sopravvivenza, adattamento e crescita, che diventano patrimonio prezioso per la loro formazione integrale.
Il ruolo della famiglia e delle relazioni significative
Un altro elemento ricorrente nelle riflessioni è l’importanza della famiglia come pilastro fondamentale nei momenti in cui la scuola non è riuscita a garantire un adeguato sostegno. Genitori, fratelli, ma anche amici e compagni di classe sono stati percepiti come figure decisive nel dare forza, incoraggiamento e motivazione.
Allo stesso tempo, viene riconosciuto il valore di quegli insegnanti che hanno saputo ascoltare, motivare e incoraggiare, dimostrando quanto la relazione educativa possa incidere profondamente sulla crescita personale. Quando la scuola riesce a creare un clima di ascolto e fiducia, può diventare un potente motore di inclusione e valorizzazione.
L’importanza della didattica esperienziale
Molti interventi sottolineano l’efficacia dei compiti di realtà e delle esperienze pratiche come strumenti didattici inclusivi. Partire da situazioni concrete e vicine agli studenti – ad esempio analizzare le etichette dei vestiti per comprendere la globalizzazione – permette di collegare i contenuti teorici con l’esperienza quotidiana.
Questo approccio favorisce non solo l’apprendimento, ma anche la partecipazione attiva degli studenti, valorizzando le loro competenze personali e culturali. La scuola, quindi, non deve limitarsi a trasmettere nozioni, ma deve diventare un luogo di esperienze e di costruzione di significati condivisi.
Verso una cultura della flessibilità
Le riflessioni raccolte mettono in evidenza una criticità del sistema scolastico: la rigidità dei programmi e delle metodologie. Spesso la mancanza di flessibilità genera esclusione e senso di inadeguatezza negli studenti.
Per superare questo limite, è necessario che la scuola promuova una cultura più attenta ai bisogni individuali, capace di riconoscere e valorizzare le differenze come risorsa. L’inclusione passa, quindi, da un cambiamento culturale che mette al centro la persona e non la prestazione.
La gestione dei casi complessi e la rete di supporto
Necessità di sostegno elevato e situazioni critiche
In alcuni contesti scolastici emergono situazioni particolarmente difficili, come quelle degli studenti con necessità di sostegno elevato o intensivo. Si tratta di casi in cui le difficoltà non sono solo didattiche, ma coinvolgono aspetti comportamentali e relazionali complessi, fino a manifestazioni di aggressività o gravi limitazioni comunicative.
In tali circostanze, l’azione educativa da sola non basta: è indispensabile attivare una rete integrata di interventi, che coinvolga insegnanti, assistenti educativi, operatori sanitari e famiglie. L’obiettivo non è solo garantire la sicurezza e la gestione quotidiana della classe, ma anche costruire percorsi che valorizzino le potenzialità residue e migliorino la qualità della vita dell’alunno.
Il valore della collaborazione interdisciplinare
La gestione dei casi complessi richiede una forte collaborazione interdisciplinare. La scuola da sola non può affrontare problematiche che necessitano anche di competenze mediche, psicologiche o sociali. È dunque essenziale il raccordo con i servizi territoriali (ASL, assistenti sociali, centri di salute mentale) e con la famiglia, che rappresenta l’ecosistema primario dell’alunno.
Un approccio realmente inclusivo deve integrare diversi livelli di intervento: educativo, relazionale, terapeutico e sociale. Solo attraverso un’azione corale è possibile rispondere in modo adeguato e sostenibile alle necessità più complesse.
La dimensione culturale dell’inclusione
La riflessione complessiva mostra come l’inclusione non possa essere ridotta a una serie di norme o di strumenti tecnici. Essa rappresenta un processo culturale e sociale che richiede cambiamento di prospettive, flessibilità e apertura alla diversità.
L’esperienza italiana, pur con le sue criticità, ha saputo affermare il principio che ogni alunno ha diritto di cittadinanza educativa. Tuttavia, restano sfide aperte: la carenza di risorse, la formazione continua dei docenti, la costruzione di una comunità educante che sappia valorizzare davvero ogni studente.
Conclusione
Dall’inserimento previsto negli anni Settanta, passando per l’integrazione degli anni Ottanta e Novanta, fino al paradigma odierno dell’inclusione, la scuola ha compiuto un percorso di trasformazione profonda. Oggi il compito principale è continuare a sviluppare una cultura dell’accoglienza che non veda la diversità come un problema da risolvere, ma come una risorsa per la crescita collettiva.
Disclaimer: I contenuti hanno carattere divulgativo e non sostituiscono materiale didattico ufficiale. Sono pensati come risorsa di supporto per lo studio e la preparazione a percorsi formativi e concorsuali.
👉 Entra nel gruppo