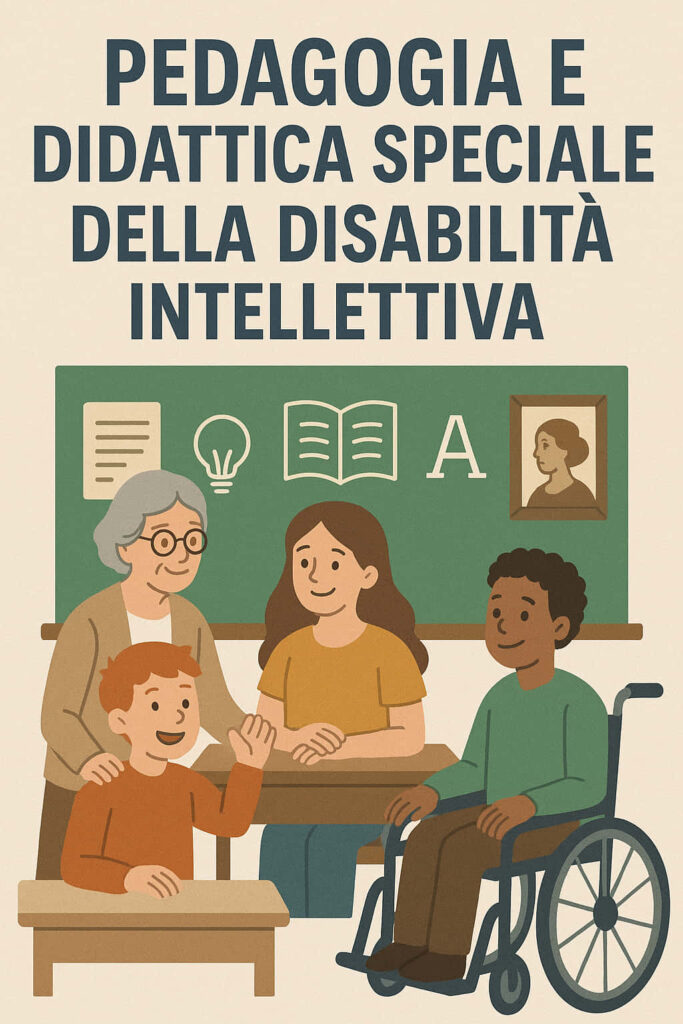Il ruolo del consiglio di classe nella redazione del PDP
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento elaborato dal consiglio di classe, con il coordinatore che si fa promotore del processo e ne assicura la stesura. Questo strumento si rivolge a studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), tra cui rientrano anche i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), ma non solo. Può infatti essere adottato anche in presenza di difficoltà legate al contesto socioculturale, linguistico o ambientale, senza che sia necessaria una certificazione clinica.
La redazione del PDP avviene in collaborazione con la famiglia e con le figure che ruotano attorno al percorso educativo dell’alunno, garantendo un approccio collegiale e condiviso.
Il PEI e le differenze con il PDP
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), a differenza del PDP, è strettamente connesso a una certificazione di disabilità. Si tratta di un documento obbligatorio, previsto dalla legge, che viene predisposto dall’équipe multidisciplinare dell’ASL in accordo con la famiglia e la scuola.
Se il PDP è uno strumento più flessibile e può essere attivato su iniziativa del consiglio di classe, il PEI rappresenta un atto formale che definisce obiettivi, strategie e modalità di valutazione specifiche per gli alunni con disabilità certificate.
La normativa di riferimento e gli strumenti previsti
Il PDP, in caso di DSA certificati, si fonda sulla Legge 170 del 2010, che tutela il diritto all’istruzione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Questo documento prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, da adattare disciplina per disciplina.
Tra gli strumenti compensativi più diffusi troviamo mappe concettuali, calcolatrice, computer con programmi di videoscrittura e sintesi vocale. Le misure dispensative, invece, possono includere la riduzione del carico di esercizi, la dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla scrittura sotto dettatura.
Ogni consiglio di classe, sulla base delle necessità dell’alunno, può specificare nel PDP le modalità di applicazione di tali strumenti nelle varie materie, con obiettivi personalizzati e criteri di valutazione coerenti.
Il Documento del 15 Maggio e gli allegati per gli Esami di Stato
Il significato del Documento del 15 Maggio
Il Documento del 15 maggio è un atto ufficiale redatto dai consigli di classe delle quinte superiori. Contiene una sintesi del percorso formativo svolto durante l’anno scolastico e rappresenta un punto di riferimento per la commissione d’esame in vista degli Esami di Stato.
Accanto al documento principale, è previsto un allegato specifico per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, che illustra le misure adottate nel corso dell’anno e le modalità con cui lo studente affronterà le prove.
Struttura dell’allegato per studenti con disabilità
L’allegato, elaborato con la collaborazione dei docenti di sostegno, contiene informazioni essenziali sullo studente, come dati anagrafici e riferimenti alla diagnosi. Segue una sezione dedicata alla presentazione dell’alunno, dove si descrivono punti di forza, difficoltà e strategie utilizzate nel percorso formativo.
Sono incluse anche indicazioni relative a:
- Condizioni di salute e terapie farmacologiche in corso, se rilevanti per la gestione scolastica.
- Strategie educative e didattiche sperimentate, con riferimento al PEI.
- Strumenti compensativi e misure dispensative adottati durante l’anno.
- Livello di partecipazione alla vita di classe e modalità di inserimento.
Questa sezione costituisce un vero e proprio riepilogo del lavoro svolto, utile a garantire continuità e coerenza durante le prove finali.
Gli adattamenti per gli Esami di Stato
Nell’allegato vengono riportate con precisione le modalità di svolgimento delle prove d’esame:
- Prima prova scritta: svolta nella stessa aula e negli stessi tempi degli altri candidati, con possibilità di utilizzare mappe, schemi guida o strumenti digitali.
- Seconda prova: personalizzata in base all’indirizzo scolastico e con eventuali adattamenti (ad esempio, prove grafiche o pratiche semplificate).
- Colloquio orale: supportato da mappe concettuali, schemi o strumenti multimediali che facilitino l’esposizione.
Qualora necessario, possono essere concessi tempi aggiuntivi e la possibilità di effettuare pause programmate, per prevenire sovraccarichi cognitivi o emotivi. In alcuni casi, si prevede la dispensa da attività specifiche (es. scrittura corsiva per studenti con disgrafia).
L’obiettivo è garantire a tutti gli studenti condizioni di equità, permettendo loro di dimostrare le competenze acquisite nel rispetto delle proprie caratteristiche individuali.
Metodologie didattiche inclusive e strategie di personalizzazione
Personalizzazione dell’apprendimento
Per garantire un apprendimento realmente inclusivo è necessario adattare la didattica alle caratteristiche dello studente. Le metodologie inclusive si fondano sull’uso di materiali semplificati, schemi, immagini e riassunti, strumenti che permettono di rendere i contenuti accessibili e comprensibili.
Un aspetto centrale è la prevedibilità dell’ambiente di apprendimento, fondamentale soprattutto per studenti con disturbi del neurosviluppo. Un contesto chiaro, strutturato e privo di sorprese riduce l’ansia e favorisce la concentrazione.
Strategie cooperative e metacognitive
Tra le pratiche più efficaci vi sono:
- Apprendimento cooperativo: il lavoro in piccoli gruppi stimola la collaborazione e promuove il senso di appartenenza.
- Peer tutoring: il supporto tra pari rinforza le relazioni e favorisce l’autoregolazione.
- Sviluppo delle competenze metacognitive: attività che aiutano lo studente a riconoscere i propri bisogni, pianificare il lavoro, monitorare i progressi e chiedere aiuto in modo consapevole.
Queste strategie favoriscono l’autonomia e potenziano la capacità di affrontare compiti complessi.
Strumenti compensativi e misure dispensative
Gli strumenti compensativi comprendono schemi, mappe concettuali, calcolatrici, computer con software dedicati e la possibilità di usufruire di tempo aggiuntivo nelle verifiche.
Le misure dispensative, invece, consistono nella riduzione del carico di esercizi, nella semplificazione delle consegne e nella personalizzazione delle prove, calibrate su diversi livelli di complessità (facile, medio, difficile).
L’obiettivo non è ridurre le aspettative, ma offrire allo studente le condizioni necessarie per esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Criteri di verifica e valutazione
La valutazione inclusiva si concentra sulla chiarezza espositiva, la coerenza logica e la capacità di applicare le conoscenze acquisite. È importante che le prove non si limitino a verificare nozioni mnemoniche, ma che stimolino lo studente a rielaborare i contenuti in base ai propri interessi.
Ad esempio, un alunno appassionato di videogiochi può essere coinvolto attraverso attività di gamification, trasformando le dinamiche del gioco in occasioni di apprendimento e collegamenti interdisciplinari (storia, geografia, lingua straniera).
Infine, la valutazione deve prevedere feedback continui e un costante monitoraggio dei progressi, valorizzando i successi dello studente e promuovendo la consapevolezza del proprio percorso di crescita.
Adattamenti delle prove d’esame per studenti con BES e disabilità
La prima prova scritta
La prima prova scritta degli Esami di Stato, di carattere ministeriale, si svolge nella stessa aula e negli stessi tempi degli altri candidati. Tuttavia, per gli studenti con bisogni educativi speciali è possibile predisporre:
- schemi guida strutturati, sviluppati durante l’anno, che forniscono un supporto concreto nell’organizzazione del testo;
- mappe concettuali o formulari personalizzati;
- la possibilità di usufruire di tempi aggiuntivi o di effettuare pause programmate, utili a prevenire situazioni di sovraccarico cognitivo o emotivo.
Un aspetto fondamentale è individuare in anticipo la tipologia di traccia più adatta allo studente (A, B o C) e allenarlo su quella, così da valorizzarne i punti di forza.
La seconda prova
La seconda prova varia in base all’indirizzo scolastico (discipline scientifiche, linguistiche, grafiche o professionali). Anche in questo caso è possibile prevedere adattamenti, come:
- prove equipollenti, che mantengono lo stesso valore legale della prova ordinaria ma sono calibrate sulle caratteristiche dello studente;
- strumenti compensativi (mappe, calcolatrice, software specifici);
- tempi supplementari, se necessario.
Per gli studenti con gravi difficoltà di scrittura, ad esempio, è possibile autorizzare l’uso del computer o la dispensa dalla grafia corsiva.
Il colloquio orale
Il colloquio orale viene personalizzato attraverso l’utilizzo di mappe concettuali, schemi visivi, supporti digitali o registrazioni audio. L’obiettivo non è semplificare i contenuti, ma offrire modalità alternative di esposizione che permettano allo studente di esprimere conoscenze e competenze in coerenza con il percorso svolto.
La durata del colloquio può essere modulata e, in caso di necessità, lo studente può usufruire di uscite temporanee dall’aula o momenti di pausa.
Documentazione da allegare
In vista degli Esami di Stato, è importante predisporre una documentazione completa e aggiornata che accompagni l’alunno, comprendente:
- Profilo funzionale e certificazioni;
- PEI o PDP;
- simulazioni delle prove d’esame;
- mappe concettuali, formulari e materiali personalizzati;
- griglie di valutazione dedicate, elaborate dai dipartimenti disciplinari, che tengano conto delle specificità dell’alunno.
Questa documentazione ha lo scopo di garantire trasparenza e uniformità, fornendo alla commissione strumenti chiari per valutare l’alunno in modo equo e coerente.
Griglie di valutazione personalizzate e criteri inclusivi
L’importanza delle griglie dedicate
Per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali è fondamentale disporre di griglie di valutazione specifiche, calibrate sui loro percorsi di apprendimento. Queste griglie non riducono il valore della prova, ma consentono di adattare gli indicatori di valutazione alle reali possibilità dello studente, garantendo equità senza abbassare le aspettative.
Le griglie vengono solitamente elaborate dai dipartimenti disciplinari e approvate dal consiglio di classe, così da avere coerenza tra docenti e trasparenza nei confronti della commissione d’esame.
Indicatori adattati
Nelle griglie inclusive, i descrittori tradizionali vengono modulati. Ad esempio:
- comprensione del testo valutata in base agli aspetti essenziali piuttosto che ai dettagli secondari;
- esposizione premiata per la chiarezza e la pertinenza anche in presenza di strutture linguistiche semplificate;
- valorizzazione delle conoscenze apprese attraverso schemi o mappe concettuali, considerate modalità pienamente legittime di rielaborazione dei contenuti.
In questo modo, lo studente può aspirare a un punteggio massimo pur seguendo un percorso personalizzato.
Verifiche equipollenti
La normativa prevede la possibilità di predisporre prove equipollenti, ossia prove che hanno lo stesso valore delle prove ordinarie, ma sono adattate nelle modalità di somministrazione o negli strumenti utilizzati. Ad esempio:
- produzione di una mappa concettuale e un audio esplicativo al posto di un tema lungo;
- verifica orale guidata con l’ausilio di immagini o schede;
- elaborati multimediali come alternativa a compiti scritti complessi.
L’obiettivo è mantenere equivalenza di contenuti e obiettivi formativi, pur attraverso modalità differenti.
Valutazione come processo formativo
La valutazione inclusiva non si limita al voto finale, ma è intesa come accompagnamento al percorso di crescita dello studente. Per questo è utile:
- fornire feedback continui;
- monitorare i progressi con strumenti di osservazione sistematica;
- coinvolgere lo studente nella riflessione metacognitiva sui propri risultati, favorendo consapevolezza e autonomia.
In questo modo, la valutazione diventa non solo misurazione, ma anche strumento educativo e motivazionale.
La pedagogia speciale: compiti, finalità e approcci
Una disciplina operativa e riflessiva
La pedagogia speciale è una disciplina che unisce riflessione teorica e azione pratica. Il suo obiettivo principale è garantire l’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità o bisogni educativi speciali, promuovendo cittadinanza attiva ed uguaglianza sostanziale.
Non si limita a compensare le difficoltà, ma punta a valorizzare la persona nella sua globalità, individuando punti di forza, interessi, motivazioni e contesti di vita. In quest’ottica, la disabilità non è più vista come somma di deficit, ma come interazione tra individuo e ambiente.
I compiti della pedagogia speciale
La pedagogia speciale può essere sintetizzata in una serie di compiti fondamentali:
- Definire criteri educativi condivisibili: la persona viene considerata nella sua interezza, non ridotta al deficit.
- Rispondere ai bisogni speciali: l’azione educativa riguarda sia l’individuo che la comunità, con l’obiettivo di ridurre barriere culturali, strutturali e didattiche.
- Promuovere cittadinanza attiva e autodeterminazione: sviluppare competenze che permettano alla persona di partecipare pienamente alla vita scolastica e sociale.
- Elaborare curricoli flessibili: superare i modelli rigidi per creare percorsi adattabili e inclusivi.
- Monitorare e valutare continuamente i processi educativi: verificare l’efficacia delle strategie adottate e apportare modifiche quando necessario.
- Sperimentare e innovare: introdurre nuove metodologie e strumenti, anche attraverso la tecnologia e la didattica universale (UDL).
Una scienza critica e progettuale
La pedagogia speciale ha una doppia natura:
- è critica, perché analizza e smaschera le logiche escludenti presenti nei sistemi educativi;
- è progettuale, perché propone percorsi innovativi e inclusivi capaci di superare tali barriere.
In questo senso, rappresenta uno strumento concreto per rendere effettivo il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, trasformando l’inclusione in una realtà vissuta a scuola, in famiglia e nel territorio.
Obiettivi SMART e progettazione educativa inclusiva
Cosa significa SMART
Nella progettazione educativa inclusiva è fondamentale definire obiettivi chiari e verificabili. A questo scopo si utilizza spesso l’acronimo SMART, che indica cinque caratteristiche essenziali:
- Specific (Specifico): l’obiettivo deve essere chiaro e concreto, non generico.
- Measurable (Misurabile): deve poter essere valutato attraverso criteri oggettivi e osservabili.
- Achievable (Raggiungibile): deve essere realistico e adeguato alle risorse e agli strumenti disponibili.
- Relevant (Rilevante): deve avere un valore concreto per lo studente, essere utile al suo percorso di crescita.
- Time-related (Temporalizzato): deve avere una scadenza chiara, definita nel tempo (giorni, settimane o mesi).
Questa impostazione, nata originariamente nel contesto del management, si è rivelata estremamente efficace anche in ambito educativo, in particolare nella didattica inclusiva.
Applicazioni pratiche degli obiettivi SMART
Un obiettivo SMART permette di monitorare i progressi dello studente in modo strutturato. Ad esempio:
- Relazionale: “Entro quattro settimane lo studente avvierà uno scambio funzionale con un compagno durante tre momenti di ricreazione, supportato da prompt visivi.”
- Comunicativo: “Da un testo breve con immagini, lo studente estrarrà cinque parole chiave e costruirà una mappa in quattro prove su cinque entro sei settimane.”
- Autonomia: “Seguendo una checklist di quattro passaggi, lo studente completerà in autonomia un’attività pratica almeno tre volte su cinque nell’arco di tre settimane.”
Questi esempi mostrano come l’obiettivo diventi concreto, osservabile e verificabile, favorendo il senso di autoefficacia.
Il valore per l’inclusione
Gli obiettivi SMART aiutano a tradurre i bisogni educativi in strategie operative. Grazie a questa metodologia:
- lo studente può comprendere meglio le aspettative e monitorare i propri progressi;
- i docenti possono verificare in maniera sistematica l’efficacia delle strategie adottate;
- la famiglia e gli operatori esterni possono collaborare con maggiore chiarezza, condividendo traguardi concreti.
In questo modo, la progettazione educativa inclusiva diventa partecipata, trasparente e orientata ai risultati, senza perdere di vista la dimensione umana e relazionale che caratterizza il percorso formativo.
Esempi di attività didattiche inclusive e monitoraggio dei progressi
Un caso pratico: cittadinanza e media
Per rendere concreti i principi della pedagogia speciale, si possono sviluppare attività didattiche inclusive progettate con obiettivi SMART. Ad esempio, in una classe di scuola secondaria di secondo grado, il tema può essere “cittadinanza e media”, con particolare attenzione al fenomeno delle fake news.
Lo studente con bisogni educativi speciali può essere supportato da strumenti come mappe visive, dettatura vocale e sintesi digitale. L’attività viene suddivisa in fasi:
- Lettura di un breve testo o di una fonte multimediale.
- Individuazione di cinque parole chiave.
- Creazione di una mappa concettuale.
- Produzione di un elaborato semplificato (testo breve o audio di sintesi).
Ruoli e cooperazione
Per favorire la partecipazione, si possono assegnare ruoli di gruppo ben definiti:
- Timekeeper: gestisce i tempi e segnala le pause.
- Reporter: raccoglie parole chiave e compila la mappa.
- Lettore: legge consegne e materiali.
- Quality check: verifica il rispetto della checklist.
- Tutor di pari: affianca lo studente nei passaggi più complessi.
Questa suddivisione incoraggia la collaborazione tra pari, stimola la responsabilità condivisa e rafforza l’inclusione.
Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio dei progressi si realizza attraverso strumenti semplici ma efficaci:
- Checklist settimanali, che documentano il raggiungimento dei passaggi previsti.
- Schede di osservazione, in cui l’insegnante annota comportamenti, strategie adottate e richieste di aiuto.
- Rubriche valutative, che stabiliscono livelli di competenza (da “non avvia” a “completa in autonomia”).
Il coinvolgimento della famiglia e di eventuali assistenti educativi o terapisti è fondamentale: ciascuno può contribuire con feedback e osservazioni, creando una rete di sostegno che rafforza la continuità educativa tra scuola e contesto extrascolastico.
Gestione del contesto e strategie preventive
Per prevenire sovraccarichi cognitivi o emotivi, si possono prevedere:
- spazi a bassa distrazione;
- tempi di lavoro scanditi in fasi brevi;
- strumenti di regolazione emotiva, come un timer visivo o script sociali essenziali;
- pause brevi e concordate.
Queste accortezze consentono allo studente di lavorare in un clima sereno e prevedibile, aumentando le possibilità di successo.
Modelli di riferimento della pedagogia speciale
Il modello medico
In passato la disabilità veniva interpretata prevalentemente attraverso il modello medico, che la considerava un problema individuale da diagnosticare, curare o riabilitare. Il focus era centrato quasi esclusivamente sul deficit e sulla patologia, riducendo la persona alla sua condizione clinica.
Esempio: un bambino con paralisi cerebrale veniva visto come “paziente da trattare”, senza valorizzarne le potenzialità residue o le competenze sviluppabili in altri ambiti.
Il modello sociale ha introdotto un cambiamento radicale di prospettiva: la disabilità non è più vista come problema della persona, ma come costruzione sociale. Le difficoltà derivano soprattutto dalle barriere architettoniche, culturali e relazionali che impediscono alla persona di esprimersi e partecipare pienamente alla vita sociale.
Esempio: una persona in carrozzina non è limitata dalla sua condizione, ma dall’assenza di un ascensore o di un percorso accessibile.
La sintesi: il modello ICF
Oggi il punto di riferimento è rappresentato dall’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell’OMS, che integra i due approcci precedenti. Secondo questo modello, la disabilità è il risultato dell’interazione tra condizioni di salute e fattori ambientali.
I concetti chiave dell’ICF sono:
- Funzionamento: le attività che la persona è in grado di svolgere, anche con supporti.
- Partecipazione: il grado di coinvolgimento nelle attività di vita quotidiana e sociale.
- Qualità della vita: la possibilità di vivere esperienze significative e gratificanti.
Esempio: uno studente ipovedente, grazie a libri digitali e testi a caratteri ingranditi, può partecipare pienamente alle attività scolastiche, dimostrando come sia l’adattamento dell’ambiente a determinare l’inclusione.
Dal paradigma della cura al paradigma dei diritti
Con l’ICF si passa dal paradigma centrato sulla cura e sul deficit a un paradigma fondato sui diritti. La disabilità non è più considerata un destino individuale, ma una sfida collettiva, che richiede la cooperazione di scuola, famiglia, istituzioni e comunità.
L’obiettivo diventa quello di rimuovere le barriere e valorizzare le differenze, riconoscendo ogni persona come portatrice di potenzialità e risorse.
Integrazione e inclusione scolastica in Italia
L’evoluzione storica
L’Italia è stata tra i Paesi pionieri nell’integrazione scolastica. Negli anni ’70, con la Legge 517/1977, furono abolite le classi speciali e gli alunni con disabilità vennero inseriti nelle classi comuni. Questa scelta segnò un passaggio fondamentale: dalla segregazione alla partecipazione.
L’insegnante di sostegno divenne la figura di riferimento per accompagnare l’alunno con disabilità nel percorso scolastico, garantendo un insegnamento individualizzato e favorendo la socializzazione.
Caratteristiche del modello italiano
Il modello italiano si basa su alcuni principi chiave:
- La classe comune è l’ambiente primario di apprendimento anche per gli alunni con disabilità.
- L’inclusione è considerata un diritto e non una concessione.
- La responsabilità educativa è collettiva: tutti i docenti sono coinvolti nel processo inclusivo, non solo l’insegnante di sostegno.
Questa impostazione ha reso l’Italia un esempio internazionale, ma presenta anche alcune fragilità.
Criticità e sfide attuali
Nonostante i progressi, permangono alcune difficoltà:
- rischio di delegare tutto al docente di sostegno, riducendo il coinvolgimento dei docenti curricolari;
- formazione non sempre adeguata degli insegnanti su metodologie inclusive;
- persistenza di pregiudizi che portano, ad esempio, a escludere lo studente con autismo dai lavori di gruppo;
- difficoltà organizzative dovute alla scarsità di risorse e alla gestione burocratica complessa.
Inclusione come processo culturale
L’integrazione non si esaurisce nell’inserimento fisico dell’alunno in classe: deve diventare inclusione, cioè un processo culturale e organizzativo che valorizzi la diversità come risorsa. La scuola, in questo senso, si configura come un laboratorio di democrazia e cittadinanza, uno spazio che riflette la società nei suoi pregi e difetti e che può educare al rispetto delle differenze.
L’inclusione non è dunque un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un percorso continuo, che richiede costanti adattamenti nelle metodologie, nella mentalità e nelle strutture scolastiche.
Principi dell’inclusione e didattica collaborativa
Centralità della persona
Alla base dell’inclusione c’è il principio della centralità della persona. Lo studente non è definito dal suo deficit, ma dalle sue potenzialità, interessi e bisogni educativi. La diversità non è un ostacolo, bensì una risorsa che arricchisce l’intera comunità scolastica.
Ogni percorso deve quindi essere personalizzato, evitando etichette e approcci standardizzati, e mirando a costruire un contesto educativo che valorizzi le specificità di ciascuno.
Comunità inclusiva
La scuola inclusiva non riguarda solo il singolo alunno, ma l’intera comunità. Ciò significa:
- costruire un ambiente accogliente, dove tutti gli studenti si sentano parte attiva;
- promuovere pratiche di collaborazione e mutuo aiuto;
- coinvolgere le famiglie e il territorio per rafforzare la rete di supporto.
Esempio concreto è il peer tutoring, in cui uno studente aiuta un compagno in difficoltà, sviluppando allo stesso tempo competenze relazionali e responsabilità condivisa.
Esempio di didattica collaborativa
Un caso emblematico è rappresentato da un’attività svolta in una lezione CLIL di geografia con uno studente straniero di origine indiana. Lo studente, padrone della lingua inglese, è diventato un punto di riferimento per la classe, fungendo da “glossario vivente” nella spiegazione dei termini tecnici.
In questo modo, la sua competenza linguistica è stata valorizzata non solo come supporto personale, ma come risorsa per l’intero gruppo. L’attività ha permesso agli altri studenti di apprendere in modo più efficace e ha rafforzato l’autostima dello studente straniero.
Inclusione come processo continuo
L’inclusione non si limita a interventi episodici: è un processo in evoluzione, che richiede modifiche costanti a livello organizzativo, metodologico e culturale. Un esempio è l’assemblea scolastica inclusiva, in cui vengono trattati temi vicini alla realtà dei ragazzi, dando spazio alle loro voci e favorendo la partecipazione di tutti.
Questo approccio trasforma la scuola in un luogo in cui si cresce insieme, in cui le differenze diventano parte integrante della normalità quotidiana.

Disponibile il nuovo volume!
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Appunti pratici per il percorso TFA Sostegno
Il libro raccoglie e rielabora in forma di appunti personali i principali argomenti affrontati durante lo studio del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, fornendo una panoramica chiara e organizzata delle tematiche trattate.
Non si tratta di dispense ufficiali, ma di un supporto pratico allo studio, pensato per chi vuole avere una sintesi ragionata e facilmente consultabile.
Bisogni Educativi Speciali: categorie, strumenti e normativa
Definizione di BES
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) è stato introdotto dal MIUR nel 2012 e rappresenta un ampliamento della prospettiva inclusiva. Non riguarda solo gli alunni con disabilità certificata o disturbi specifici dell’apprendimento, ma tutti coloro che, per varie ragioni, necessitano di una personalizzazione del percorso scolastico.
Questa visione supera l’idea di inclusione come risposta esclusivamente clinica, estendendola anche a difficoltà di natura linguistica, culturale o socioeconomica.
Le principali categorie di BES
I BES si articolano in tre grandi categorie:
- Disabilità – regolata dalla Legge 104/1992, prevede la redazione del PEI con il coinvolgimento dell’ASL, della scuola e della famiglia.
- Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – disciplinati dalla Legge 170/2010, comprendono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. In questi casi si utilizza il PDP, con strumenti compensativi e misure dispensative.
- Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale – riguarda alunni stranieri neoarrivati, rifugiati politici o studenti con difficoltà legate al contesto familiare e sociale. Anche in questo caso il consiglio di classe può predisporre un PDP.
Strumenti e misure
Gli strumenti a disposizione per supportare gli studenti con BES comprendono:
- PEI (Piano Educativo Individualizzato): per gli alunni con disabilità certificata.
- PDP (Piano Didattico Personalizzato): per DSA e altri BES, con indicazione di strategie, strumenti compensativi e misure dispensative.
- Misure compensative: mappe concettuali, calcolatrice, computer con sintesi vocale.
- Misure dispensative: riduzione del carico di compiti, esonero da alcune prestazioni (es. lettura ad alta voce).
Prospettiva inclusiva
L’adozione di strumenti e misure non deve essere vista come un privilegio, ma come un diritto educativo. In questa prospettiva, l’uso di strumenti compensativi diventa parte integrante del percorso formativo, finalizzato a garantire pari opportunità di apprendimento.
La didattica inclusiva si fonda sull’Universal Design for Learning (UDL), che propone ambienti di apprendimento flessibili e accessibili a tutti, trasformando i supporti in strumenti di cittadinanza e partecipazione.
Inclusione digitale e tecnologie assistive
Il rischio dell’esclusione digitale
Nell’attuale società, caratterizzata da un forte sviluppo tecnologico, l’accesso agli strumenti digitali è diventato un requisito fondamentale per la piena partecipazione alla vita scolastica e sociale. Tuttavia, non tutti gli studenti hanno le stesse opportunità. La mancanza di dispositivi adeguati o di connessione internet può generare una nuova forma di disuguaglianza: la discriminazione digitale.
Esempio: uno studente ipovedente che non dispone di uno screen reader non può accedere ai contenuti come i suoi compagni, rimanendo escluso da attività fondamentali.
Tecnologie come opportunità
Le tecnologie, se ben utilizzate, rappresentano invece un potente strumento di inclusione. Alcuni esempi di tecnologie assistive sono:
- Sintesi vocale per studenti con dislessia o difficoltà di lettura.
- Screen reader e display braille per studenti non vedenti.
- Software di videoscrittura con correttore ortografico per studenti con disgrafia.
- Piattaforme collaborative per favorire il lavoro di gruppo anche a distanza.
Questi strumenti permettono agli studenti di esprimere le proprie competenze e partecipare attivamente, riducendo le barriere legate alla disabilità o al contesto socioeconomico.
La didattica digitale inclusiva
Un approccio inclusivo alla tecnologia deve garantire:
- Accessibilità dei materiali, con testi leggibili, immagini con descrizioni e font ad alta leggibilità.
- Flessibilità nelle consegne, consentendo l’uso di supporti alternativi (video, registrazioni audio, mappe).
- Scelta tra diverse modalità di espressione, per valorizzare i punti di forza di ciascuno.
In questo senso, la tecnologia non è un fine in sé, ma un mezzo per rendere l’apprendimento più equo e partecipativo.
Videogiochi e gamification come strumenti educativi
Anche i videogiochi, se inseriti in un percorso didattico strutturato, possono diventare strumenti di inclusione. Titoli come Assassin’s Creed o Minecraft offrono ambientazioni storiche e geografiche che possono essere sfruttate per attività interdisciplinari.
Esempio: chiedere agli studenti di ricostruire con Minecraft i monumenti della propria città, integrando conoscenze di storia, geografia e arte, rafforza la motivazione e favorisce l’apprendimento collaborativo.
La gamification, quindi, non sostituisce il sapere teorico, ma può fungere da stimolo e rinforzo, rendendo più coinvolgente l’acquisizione delle conoscenze.
Il ruolo della scuola e dei docenti nell’inclusione
Una responsabilità collegiale
L’inclusione non può essere delegata esclusivamente all’insegnante di sostegno: è una responsabilità condivisa da tutto il consiglio di classe. Ogni docente, con la propria disciplina, contribuisce a costruire un percorso formativo accessibile e significativo per tutti gli studenti.
La progettazione didattica deve essere collegiale, con una costante collaborazione tra docenti, famiglie e servizi territoriali.
Personalizzazione e corresponsabilità
La scuola inclusiva si fonda sulla personalizzazione dell’insegnamento, che non significa abbassare il livello degli obiettivi, ma adattarli alle caratteristiche di ciascun alunno. Questo richiede:
- flessibilità nei metodi didattici;
- predisposizione di percorsi alternativi;
- capacità di riconoscere e valorizzare i punti di forza degli studenti.
La corresponsabilità implica che tutti i docenti si sentano parte attiva del percorso, evitando che l’alunno venga percepito come “compito esclusivo” del sostegno.
Collaborazione con famiglie e servizi
La sinergia con le famiglie e con le figure educative ed eventualmente terapeutiche esterne è fondamentale. Gli assistenti educativi e i terapisti possono supportare lo studente anche al di fuori dell’orario scolastico, garantendo continuità. La famiglia, dal canto suo, offre un punto di vista privilegiato sui bisogni e le potenzialità del figlio.
Questa rete di collaborazione permette di rendere l’intervento più efficace, coerente e globale.
Inclusione come diritto umano
L’inclusione non è solo un obiettivo pedagogico, ma un diritto umano sancito anche a livello internazionale, come nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006). La scuola diventa quindi un luogo di cittadinanza, dove si sperimentano i valori di equità, partecipazione e rispetto delle differenze.
Educare all’inclusione significa educare alla democrazia, formando cittadini consapevoli e responsabili.
Sfide attuali e prospettive future dell’inclusione scolastica
Il contesto scolastico di oggi è profondamente cambiato rispetto al passato. La società contemporanea è caratterizzata da pluralismo culturale, mobilità internazionale e disuguaglianze economiche. Sempre più spesso le scuole accolgono studenti rifugiati o con esperienze traumatiche legate a guerre e migrazioni, che portano con sé fragilità psicologiche e bisogni complessi.
Allo stesso tempo, la pressione sociale e il confronto con i coetanei (si pensi al possesso di dispositivi tecnologici o abiti firmati) possono diventare motivo di esclusione o disagio, con il rischio di marginalizzazione.
Il ruolo della tecnologia
Le tecnologie digitali aprono grandi opportunità, ma pongono anche nuove sfide. Se da un lato strumenti come screen reader, sintesi vocale o piattaforme inclusive facilitano l’apprendimento, dall’altro permane il rischio dell’esclusione digitale per chi non ha accesso a dispositivi o connessioni adeguate.
Sarà quindi cruciale garantire a tutti gli studenti non solo strumenti compensativi, ma anche un’alfabetizzazione digitale equa, che consenta loro di vivere da protagonisti nella società della conoscenza.
Formazione dei docenti
Un altro nodo fondamentale riguarda la formazione continua degli insegnanti. Per realizzare una vera scuola inclusiva, è necessario che tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, acquisiscano competenze pedagogiche, didattiche e relazionali utili a gestire la diversità in classe.
Investire nella formazione significa costruire una cultura scolastica realmente condivisa, capace di superare pregiudizi e deleghe.
Verso una scuola inclusiva e resiliente
L’inclusione non è un traguardo statico, ma un processo dinamico e continuo. Richiede adattamenti costanti, innovazione metodologica e apertura culturale.
Le prospettive future dovranno orientarsi verso:
- un uso più diffuso delle metodologie attive (cooperative learning, peer tutoring, gamification);
- una progettazione educativa basata su obiettivi personalizzati e SMART;
- il rafforzamento della collaborazione tra scuola, famiglie e territorio;
- politiche scolastiche capaci di garantire risorse adeguate e continuità di intervento.
La scuola inclusiva è, in definitiva, il luogo in cui crescere insieme, dove le differenze non sono barriere, ma ponti per costruire una società più giusta ed equa.
Disclaimer: I contenuti hanno carattere divulgativo e non sostituiscono materiale didattico ufficiale. Sono pensati come risorsa di supporto per lo studio e la preparazione a percorsi formativi e concorsuali.
👉 Entra nel gruppo