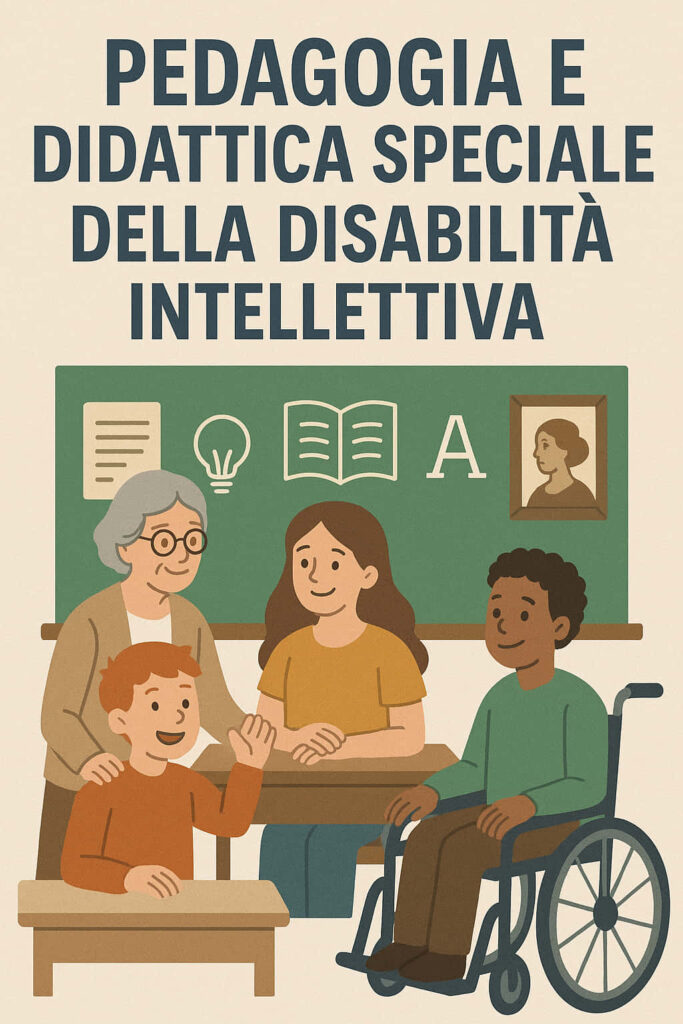Introduzione
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) rappresenta uno strumento fondamentale per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La sua funzione non si limita a definire interventi didattici personalizzati, ma mira a considerare la persona nella sua globalità, valorizzando potenzialità, contesto di vita e bisogni educativi. Negli ultimi anni il modello di PEI ha subito una significativa trasformazione normativa e culturale, passando da un approccio centrato sulla certificazione a uno orientato al funzionamento globale della persona e al ruolo del contesto come facilitatore o barriera dell’apprendimento.
Struttura e dimensioni del PEI
La prima dimensione del PEI riguarda la capacità dell’alunno di relazionarsi con compagni e adulti, sia all’interno della classe sia negli spazi esterni. Vengono analizzate le modalità di partecipazione, i punti di forza e le difficoltà, nonché le strategie che favoriscono l’integrazione. Ad esempio, per studenti nello spettro autistico è essenziale utilizzare un linguaggio chiaro e privo di metafore, in quanto l’ironia e le espressioni figurative possono creare incomprensioni.
La partecipazione ad attività extracurricolari, come viaggi di istruzione o esperienze di gruppo, rappresenta un’opportunità preziosa per consolidare legami con i pari. Tuttavia, situazioni di forte stimolazione (ambienti affollati, rumori, stress) possono generare difficoltà emotive e comportamentali, richiedendo un supporto adeguato.
Comunicazione e linguaggio
In questa dimensione si valutano le competenze comunicative, influenzate da fattori emotivi, cognitivi e psicologici. Per studenti con disturbi del neurosviluppo, come l’autismo, è fondamentale proporre modalità comunicative accessibili: uso di immagini, linguaggio semplificato, mappe concettuali. Nonostante le difficoltà, molti studenti riescono a esprimere bisogni e richieste, dimostrando capacità di auto-advocacy se adeguatamente supportati.
Autonomia e orientamento
Il PEI considera anche la capacità di orientarsi negli spazi scolastici ed extrascolastici e di gestire le attività quotidiane. Rientrano in questa area aspetti come l’uso della tecnologia, la motricità fine e globale, la cura dell’igiene personale e l’organizzazione del materiale scolastico. L’autonomia è strettamente collegata al grado di partecipazione sociale e al livello di indipendenza che lo studente riesce a sviluppare.
Dimensione cognitiva e neuropsicologica
Questa sezione analizza le capacità cognitive e le difficoltà specifiche del neurosviluppo. Gli studenti nello spettro autistico, ad esempio, possono manifestare compromissioni nella comprensione delle emozioni altrui e nell’empatia, con conseguenti difficoltà nelle interazioni sociali. Le strategie di supporto includono strumenti compensativi (planner, mappe concettuali, classroom digitali personalizzate), scaffolding progressivo e attività metacognitive che aiutino lo studente a riflettere sul proprio apprendimento.
Interventi e obiettivi educativi
Definizione degli obiettivi
Gli obiettivi del PEI vengono definiti a partire dalle diverse dimensioni considerate (relazionale, comunicativa, cognitiva, motoria, ecc.). Per ciascuna area si descrivono i punti di partenza e si stabiliscono traguardi realistici e misurabili.
Ad esempio, nella dimensione socio-relazionale l’obiettivo può essere quello di migliorare la capacità dello studente di autoregolarsi nella gestione dei rapporti con i pari, partecipando a conversazioni su tematiche comuni.
Strategie educative
Le strategie da adottare devono favorire la partecipazione attiva e inclusiva. Tra le più efficaci si segnalano:
- Cooperative Learning: attività di gruppo basate sulla collaborazione.
- Peer Tutoring: supporto reciproco tra compagni.
- Apprendimento collaborativo con domande stimolo, problem solving e situazioni reali che valorizzino gli interessi personali dello studente.
- Apprendimento metacognitivo: incoraggiare riflessioni sul proprio percorso di apprendimento.
- Uso di tecnologie didattiche: strumenti digitali, smartphone, computer, LIM e piattaforme online.
- Feedback costante e positivo: valorizzare i progressi e normalizzare gli errori come tappe del processo di apprendimento.
Comunicazione e linguaggio
Per studenti con difficoltà comunicative, gli obiettivi includono l’aumento della concentrazione, la coerenza rispetto al compito e lo sviluppo di modalità di espressione più funzionali. Le strategie prevedono:
- utilizzo di mappe concettuali e schemi visivi;
- domande aperte e sfide concrete;
- rinforzi positivi per sostenere l’autostima;
- personalizzazione del linguaggio per renderlo comprensibile e diretto.
Autonomia e orientamento
In quest’area, gli obiettivi riguardano la crescita delle competenze necessarie alla gestione indipendente delle attività quotidiane e scolastiche. Si fa uso di strumenti compensativi (es. prompting verbale e visivo), tutoraggio tra pari e attività guidate. L’esito atteso è che lo studente acquisisca maggiore indipendenza, ad esempio imparando a usare software specifici legati al proprio indirizzo di studi.
Dimensione cognitiva e neuropsicologica
Il lavoro in questa dimensione punta al potenziamento delle funzioni cognitive, come memoria, attenzione e problem solving. Alcuni strumenti utili sono:
- planner e agende per la gestione delle verifiche;
- piattaforme digitali (es. Google Classroom) con materiali semplificati;
- mappe concettuali, schemi o riassunti personalizzati;
- strategie di scaffolding con supporto progressivo e graduale riduzione dell’aiuto;
- esercizi di autovalutazione e riflessione metacognitiva.
L’obiettivo non è sostituirsi allo studente, ma fornirgli tutti gli strumenti necessari affinché possa svolgere i compiti in autonomia, accettando anche la possibilità di errori come parte integrante del processo di apprendimento.
Osservazioni del contesto: barriere e facilitatori
Risorse facilitanti
Il PEI tiene conto non solo delle caratteristiche individuali dello studente, ma anche delle risorse presenti nel contesto di vita e di apprendimento. Tra i principali facilitatori troviamo:
- La famiglia, quando partecipa attivamente e collabora con la scuola.
- Il team docente, la cui disponibilità e apertura favoriscono l’attuazione di strategie inclusive.
- La partecipazione sociale: l’alunno può essere inserito in attività culturali, sportive o di volontariato (come la Protezione Civile), che rafforzano il senso di appartenenza e la cittadinanza attiva.
Barriere
Accanto alle risorse, è fondamentale individuare gli ostacoli che possono ostacolare il percorso educativo. Tra le barriere più frequenti si segnalano:
- ambienti scolastici troppo rumorosi o caotici, che aumentano il sovraccarico sensoriale;
- assenza di strumenti adeguati o tecnologie compensative;
- scarsa flessibilità organizzativa da parte della scuola;
- atteggiamenti poco inclusivi da parte di compagni o adulti di riferimento.
Interventi sul contesto
Individuare barriere e facilitatori permette di progettare interventi mirati anche sul contesto, non solo sull’alunno. Alcuni esempi:
- organizzare lo spazio aula per ridurre i fattori di distrazione;
- programmare momenti di lavoro a piccolo gruppo o in coppia;
- garantire la possibilità di pause brevi in caso di sovraccarico emotivo o sensoriale;
- assicurare la disponibilità di strumenti tecnologici (tablet, software specifici, sintesi vocale, mappe digitali);
- promuovere attività cooperative che favoriscano la collaborazione tra pari.
Questa prospettiva mette in evidenza come l’inclusione scolastica non dipenda solo dalle caratteristiche dell’alunno, ma dalla capacità dell’ambiente di adattarsi e diventare realmente accogliente.

Disponibile il nuovo volume!
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Appunti pratici per il percorso TFA Sostegno
Il libro raccoglie e rielabora in forma di appunti personali i principali argomenti affrontati durante lo studio del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, fornendo una panoramica chiara e organizzata delle tematiche trattate.
Non si tratta di dispense ufficiali, ma di un supporto pratico allo studio, pensato per chi vuole avere una sintesi ragionata e facilmente consultabile.
Modalità di sostegno didattico
Supporto individuale e di gruppo
Il PEI prevede diverse modalità di sostegno che possono variare in base alla situazione dello studente e agli obiettivi formativi. In alcuni casi può essere utile uscire dall’aula per ripassare o affrontare compiti specifici in un ambiente più tranquillo. Tuttavia, l’obiettivo primario resta sempre l’inclusione: l’uscita dall’aula deve essere pensata come un supporto temporaneo e non come una prassi abituale.
Un approccio efficace consiste nel lavorare con piccoli gruppi di compagni, scelti in modo da favorire relazioni positive e supporto reciproco. In questo modo lo studente non percepisce il sostegno come un intervento isolato, ma come parte integrante della dinamica scolastica.
Gestione del sovraccarico
In situazioni di sovraccarico emotivo o sensoriale (rumore, confusione, stress), lo studente può aver bisogno di momenti di pausa o di spazi protetti. Anche in questo caso, l’accompagnamento deve essere calibrato per garantire la continuità del percorso inclusivo e favorire un graduale ritorno in classe.
Progettazione disciplinare
Tipologie di PEI in base alla progettazione
La progettazione disciplinare rappresenta una delle parti più delicate del PEI, poiché definisce come lo studente affronterà il percorso didattico e quali titoli potrà conseguire. Le tipologie previste sono tre:
Percorso A – Ordinario
- Segue la progettazione didattica della classe.
- È destinato principalmente a studenti con disabilità fisiche che non compromettono l’apprendimento cognitivo.
- Gli obiettivi didattici sono analoghi a quelli della classe e il titolo finale è il diploma.
Percorso B – Personalizzato
- Prevede obiettivi riconducibili a quelli della classe, ma con adattamenti e personalizzazioni (mappe concettuali, schemi, prove semplificate).
- Le verifiche sono equipollenti, ossia valutano le stesse competenze della classe ma con modalità adeguate alle difficoltà dell’alunno.
- Anche in questo caso si consegue il diploma.
Percorso C – Differenziato
- È riservato a studenti con disabilità gravi che richiedono un sostegno elevato.
- Gli obiettivi non sono equipollenti a quelli della classe.
- Non viene rilasciato il diploma, ma un attestato di credito formativo.
- È sufficiente che anche una sola disciplina sia programmata con il percorso C perché l’intero PEI venga considerato differenziato.
Ruolo dei docenti curricolari
Il PEI non sostituisce il progetto individuale, ma ne è parte integrante. I docenti curricolari hanno il compito di:
- organizzare spazi e tempi di apprendimento;
- predisporre mediatori didattici (mappe, formulari, strumenti tecnologici);
- raccordare le attività scolastiche con quelle extracurriculari;
- definire modalità di valutazione chiare, realistiche e coerenti con il percorso scelto.
Per gli studenti con percorso B o C è possibile predisporre griglie di valutazione personalizzate, che tengano conto degli obiettivi specifici stabiliti nel PEI e garantiscano una valutazione equa e trasparente.
Il quadro normativo del nuovo PEI
Evoluzione legislativa
Il nuovo modello di PEI si inserisce in un percorso normativo volto a rafforzare l’inclusione scolastica. La cornice di riferimento parte dalla Legge 104/1992, che ha sancito il diritto all’integrazione scolastica delle persone con disabilità, ed è stata successivamente arricchita da provvedimenti più recenti, come il Decreto legislativo 66/2017, che ha introdotto importanti novità in termini di progettazione e valutazione.
Il passaggio più significativo riguarda il superamento di un approccio centrato unicamente sulla certificazione clinica, a favore di una prospettiva biopsico-sociale ispirata all’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento). In questo modo, la persona non viene definita dal deficit, ma dalla combinazione di risorse, bisogni e interazioni con il contesto.
Il ruolo del GLO
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) rappresenta il cuore del processo inclusivo. È un organo collegiale che riunisce tutte le figure significative coinvolte nel percorso dello studente:
- docenti curricolari e di sostegno;
- la famiglia;
- specialisti sanitari e sociosanitari (neuropsichiatri, terapisti, educatori);
- eventuali altre figure di supporto.
Le principali funzioni del GLO sono:
- Elaborare e approvare il PEI, partendo dal profilo di funzionamento e dalle osservazioni dirette;
- Monitorare periodicamente l’efficacia degli interventi, ricalibrando strategie e obiettivi;
- Valutare i progressi dello studente e proporre eventuali risorse per l’anno scolastico successivo.
Un processo condiviso e flessibile
Il PEI è un documento dinamico che si costruisce insieme. La presenza della famiglia e di specialisti esterni garantisce un approccio globale, mentre la collaborazione tra scuola e territorio rafforza la coerenza degli interventi.
Un aspetto innovativo riguarda la partecipazione attiva dello studente, che – se ritenuto opportuno – può essere invitato a partecipare al GLO, anche se minorenne. In questo modo si valorizza il principio di autodeterminazione, favorendo la consapevolezza e la responsabilità del ragazzo o della ragazza rispetto al proprio percorso di vita.
Struttura del nuovo PEI
Le sezioni principali
Il nuovo modello di PEI è articolato in 12 sezioni interconnesse, pensate per guidare una progettazione completa e coerente. Le aree fondamentali comprendono:
- Analisi del contesto di vita (famiglia, scuola, ambiente sociale);
- Profilo di funzionamento e diagnosi;
- Progetto individuale, se presente;
- Osservazioni sullo studente in merito a relazioni, comunicazione, autonomia e dimensione cognitiva;
- Definizione degli obiettivi educativi e didattici;
- Interventi e strategie metodologiche;
- Criteri di valutazione e monitoraggio;
- Organizzazione delle risorse (ore di sostegno, figure educative, strumenti).
Questa impostazione consente di considerare lo studente nella sua globalità e di creare una rete tra scuola, famiglia e territorio.
Dal vecchio al nuovo approccio
Il nuovo PEI segna un vero cambiamento culturale:
- Nel modello precedente, l’attenzione era rivolta per l’80% alla certificazione clinica e solo per il 20% al contesto.
- Nel modello attuale, la prospettiva si è ribaltata: il contesto e la progettazione condivisa hanno un ruolo centrale, mentre la certificazione assume un peso più ridotto.
Questo passaggio permette di spostare il focus dalle carenze dell’alunno alle sue potenzialità e al modo in cui l’ambiente può diventare un facilitatore di apprendimento.
Principi fondamentali del PEI
Il PEI adotta il modello dell’ICF, considerando la persona nella sua interezza e analizzando l’interazione tra condizioni di salute, risorse personali e fattori contestuali.
Corresponsabilità educativa
L’inclusione non è compito esclusivo del docente di sostegno, ma di tutta la comunità scolastica: docenti curricolari, personale ATA, famiglie e compagni di classe.
Autodeterminazione dello studente
Ogni studente deve poter partecipare, per quanto possibile, alla definizione del proprio progetto di vita. Anche gli studenti minorenni possono essere coinvolti nel GLO, se ritenuto opportuno dalla famiglia e dagli specialisti.
Valutazione continua
La valutazione non è un momento finale, ma un processo dinamico che accompagna l’intero anno scolastico. Essa comprende:
- valutazione diagnostica iniziale;
- verifiche intermedie;
- valutazione formativa finale.
L’obiettivo è monitorare i progressi rispetto agli obiettivi personalizzati e ricalibrare gli interventi in itinere, garantendo la massima efficacia.
Strumenti e metodologie inclusive
Strumenti compensativi e tecnologici
Il nuovo PEI valorizza l’uso di strumenti compensativi che rendono l’apprendimento più accessibile. Tra i più utilizzati troviamo:
- Mappe concettuali e schemi: utili per semplificare e visualizzare i concetti chiave.
- Planner e agende digitali: per organizzare verifiche, consegne e attività quotidiane.
- Piattaforme online (es. Google Classroom): in cui raccogliere materiali semplificati, schede e sintesi delle lezioni.
- Strumenti digitali multimediali: smartphone, tablet, software di sintesi vocale e applicazioni per la scrittura facilitata.
La scelta dello strumento deve sempre tener conto dello stile cognitivo e delle preferenze dello studente: alcuni alunni traggono maggior beneficio da mappe grafiche, altri da riassunti testuali.
Strategie metodologiche
Per garantire un apprendimento realmente inclusivo, le strategie devono essere diversificate e flessibili:
- Apprendimento cooperativo: valorizzare la collaborazione tra pari attraverso attività di gruppo strutturate.
- Peer tutoring: favorire il supporto reciproco e la responsabilizzazione degli studenti.
- Scaffolding: fornire un sostegno iniziale che viene progressivamente ridotto per promuovere autonomia.
- Problem solving e domande stimolo: stimolare la riflessione critica e l’applicazione pratica delle conoscenze.
- Feedback costante e positivo: rinforzare i successi e trasformare gli errori in occasioni di apprendimento.
Esempi pratici
Un esempio significativo riguarda l’uso dello sketchnote con studenti con stile cognitivo visivo e propensione al disegno. In questo caso, i concetti chiave di discipline come matematica o storia vengono tradotti in immagini e schemi grafici, facilitando la memorizzazione e la comprensione.
Un altro esempio è l’adozione di presentazioni alternative per studenti con sindrome di Tourette o con forte ansia sociale: invece di esporre oralmente davanti alla classe, lo studente può presentare un elaborato registrato in formato audio o video.
Queste strategie mostrano come l’inclusione non significhi abbassare il livello di apprendimento, ma fornire modalità diverse e personalizzate per raggiungere gli stessi obiettivi.
I compiti della pedagogia speciale
Una scienza critica e progettuale
La pedagogia speciale non è solo riflessione teorica, ma una disciplina che unisce analisi critica e azione educativa. Il suo obiettivo è fornire strumenti concreti per rispondere ai bisogni educativi speciali e favorire l’inclusione, garantendo allo studente la possibilità di vivere una cittadinanza attiva e un’autodeterminazione reale.
Compito 1: Definire criteri educativi condivisi
Il primo compito consiste nell’elaborare principi e linee guida che permettano di considerare la persona nella sua globalità, superando una visione riduttiva centrata sul deficit. La progettazione deve valorizzare i punti di forza, le motivazioni e gli interessi dello studente, mettendoli al centro del percorso formativo.
La pedagogia speciale agisce non solo a livello individuale, ma anche comunitario. Mira a ridurre le barriere culturali e strutturali che ostacolano la partecipazione. Un esempio emblematico: la barriera non è la carrozzina, ma la scuola senza ascensore.
Compito 3: Rendere la didattica efficace
Una didattica è inclusiva se riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati nel PEI, abilitando lo studente a diventare parte attiva della comunità scolastica. Le strategie speciali (mappe, sintesi vocale, strumenti digitali) non sono solo a beneficio degli studenti con BES, ma arricchiscono l’intera didattica, diventando utili a tutta la classe.
Compito 4: Offrire un quadro teorico
La pedagogia speciale deve fornire un impianto teorico che orienti la progettazione curricolare e organizzativa. Un principio chiave è l’Universal Design for Learning (UDL), che promuove flessibilità e capacità di prevenire le difficoltà. Ciò implica curricoli adattabili a esigenze differenti, non solo fisiche ma anche cognitive e relazionali.
Compito 5: Valutare criticamente i processi
Le pratiche educative devono essere monitorate e riviste costantemente. Il PEI, infatti, è soggetto a verifiche intermedie e finali, con la possibilità di apportare modifiche in itinere. La valutazione ha una valenza non solo tecnica, ma anche etica e politica, poiché riguarda la qualità dell’inclusione scolastica e il diritto allo studio.
Compito 6: Affrontare le questioni scolastiche fondamentali
La pedagogia speciale deve individuare le questioni centrali dell’educazione inclusiva, che ruotano attorno a tre dimensioni:
- Il soggetto, inteso come persona parte di un ecosistema, non isolata.
- L’oggetto, cioè l’educazione e l’istruzione in quanto processi formativi.
- La progettazione, ovvero la didattica efficace che attiva percorsi di autodeterminazione.
Una finalità costituzionale
In sintesi, la pedagogia speciale è chiamata a smascherare le logiche escludenti e a proporre percorsi innovativi, anche grazie alle nuove tecnologie. La sua finalità ultima è rendere effettivo il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, garantendo a ogni studente l’opportunità di realizzare il proprio progetto di vita.
Domande frequenti e casi pratici
Passaggio tra programmazioni
È possibile passare da una programmazione con obiettivi personalizzati a una differenziata (o viceversa)? Sì, il PEI è un documento dinamico: in base ai risultati e alle verifiche intermedie, il GLO può deliberare modifiche durante l’anno scolastico. Generalmente, nei primi anni di scuola superiore si parte da obiettivi personalizzati riconducibili a quelli della classe, salvo poi riorientare il percorso se le difficoltà si rivelano troppo rilevanti.
Partecipazione dello studente al GLO
Uno studente può partecipare al GLO? Sì. Se è maggiorenne, ha pieno diritto di firmare e partecipare attivamente. Anche gli studenti minorenni, se ritenuto opportuno dalla famiglia e dagli specialisti, possono essere coinvolti nelle riunioni, favorendo così il principio di autodeterminazione.
Griglie di valutazione
Le griglie di valutazione personalizzate sono strumenti fondamentali per rendere chiari i criteri con cui lo studente verrà valutato. Possono essere elaborate dai dipartimenti disciplinari o dai docenti, e spesso vengono allegate al Documento del 15 maggio per gli studenti del quinto anno, così da garantire trasparenza anche in sede d’esame di Stato.
Obiettivi minimi e personalizzati
Le vecchie diciture “obiettivi minimi” sono state sostituite da “obiettivi personalizzati”, che risultano più inclusive e coerenti con l’approccio attuale. L’obiettivo non è abbassare gli standard, ma rendere i contenuti riconducibili a quelli della classe attraverso adattamenti mirati.
Il ruolo del PEI negli esami di Stato
Il PEI ha un’importanza determinante anche nella valutazione finale e negli esami di Stato:
- Percorso A (ordinario) → lo studente sostiene le prove come la classe e consegue il diploma.
- Percorso B (personalizzato) → le prove sono equipollenti e tarate sulle difficoltà specifiche, ma consentono comunque il conseguimento del diploma.
- Percorso C (differenziato) → lo studente non ottiene il diploma, ma un attestato di credito formativo.
Per i percorsi B e C possono essere predisposte prove semplificate, suddivise in livelli di difficoltà, così da rispettare il principio di inclusione senza ridurre le opportunità di apprendimento.
Conclusioni
Il nuovo modello di PEI rappresenta uno strumento strategico per costruire percorsi educativi realmente inclusivi. La sua forza risiede nella condivisione tra scuola, famiglia e territorio, nella capacità di adattarsi alle esigenze individuali e nel riconoscere lo studente come protagonista attivo del proprio percorso di crescita.
La pedagogia speciale, attraverso i suoi compiti critici e progettuali, offre il quadro teorico e operativo per trasformare la scuola in un ambiente capace di rimuovere barriere, valorizzare potenzialità e garantire il diritto all’uguaglianza sostanziale.
Disclaimer: I contenuti hanno carattere divulgativo e non sostituiscono materiale didattico ufficiale. Sono pensati come risorsa di supporto per lo studio e la preparazione a percorsi formativi e concorsuali.
👉 Entra nel gruppo