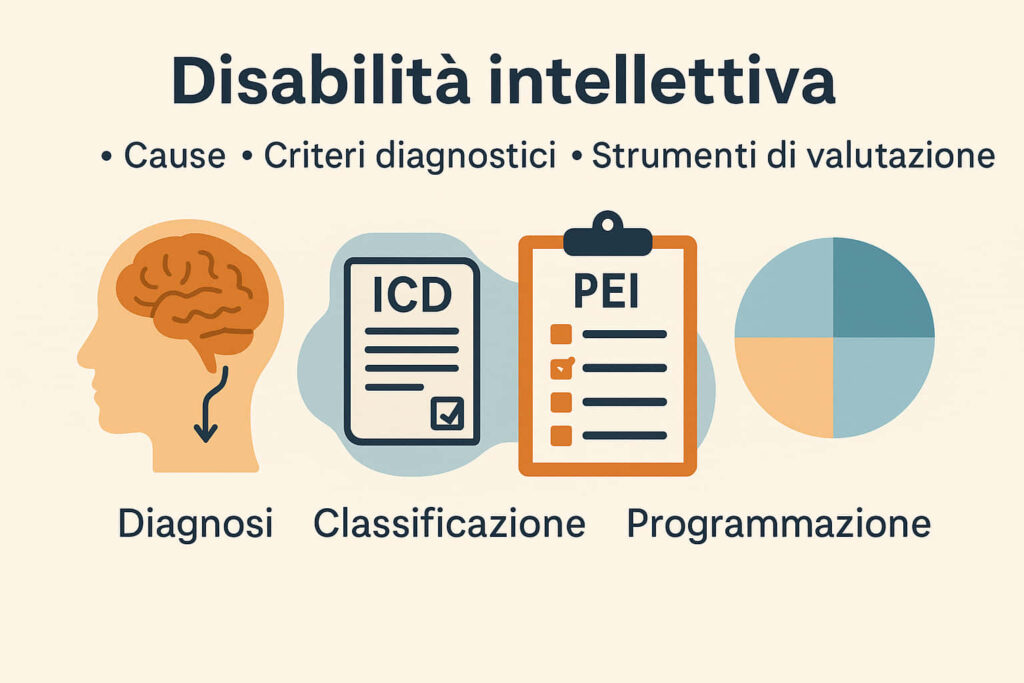Disabilità intellettiva: definizioni, criteri e prospettiva educativa
Che cos’è la disabilità intellettiva e perché non si parla più di “ritardo mentale”
Inquadramento generale
La disabilità intellettiva indica una condizione di sviluppo caratterizzata da limitazioni significative nelle abilità cognitive e nel funzionamento adattivo, con esordio nell’età evolutiva. Non riguarda solo quanto una persona sa o ricorda, ma come riesce a usare ciò che sa nella vita quotidiana, nelle relazioni e nelle attività pratiche. È una condizione che si manifesta sempre all’interno di un contesto sociale preciso, con aspettative, regole e opportunità che influenzano il modo in cui il funzionamento appare e viene valutato.
Dal termine “ritardo mentale” a “disabilità intellettiva”
Il lessico è cambiato perché è cambiata la prospettiva. Il termine “ritardo mentale” nasce in una stagione centrata quasi esclusivamente sul deficit cognitivo misurato da test standardizzati. L’evoluzione scientifica e culturale ha portato a preferire “disabilità intellettiva”, espressione che comprende non solo il profilo cognitivo, ma anche il comportamento adattivo e l’interazione con l’ambiente. La scelta linguistica è anche etica: si evita un’etichetta connotata negativamente e si adotta un termine più rispettoso e aderente al quadro concettuale attuale.
Cosa significa considerare il contesto
Oggi la disabilità intellettiva si legge su più dimensioni: abilità intellettive, abilità sociali, autonomia pratica, salute, partecipazione e fattori ambientali. Le stesse abilità possono apparire più o meno efficaci a seconda delle richieste dell’ambiente e dei sostegni disponibili. Per questo la valutazione non si esaurisce in un punteggio, ma integra osservazioni qualitative, storia evolutiva e qualità dei supporti garantiti.
Esordio e traiettoria
La condizione origina nell’età dello sviluppo e tende a emergere con evidenza quando aumentano le richieste scolastiche e sociali. Il profilo può modificarsi nel tempo: interventi educativi mirati, riabilitazione e sostegni individualizzati possono migliorare in modo concreto l’autonomia e la partecipazione, pur nel rispetto delle caratteristiche personali.
Quadri di riferimento – ICD/ICD-11, DSM-5, ICF e AAIDD in sintesi
ICD e ICD-11 in breve
La classificazione ICD descrive i disturbi dello sviluppo intellettivo come condizioni con esordio nell’età evolutiva, caratterizzate da limitazioni nelle funzioni intellettive e nel comportamento adattivo. L’ICD-11 aggiorna termini e criteri, sottolineando la valutazione del funzionamento adattivo, l’importanza del contesto e l’uso di descrittori di gravità orientati al supporto necessario nella vita quotidiana.
DSM-5 in breve
Il DSM-5 definisce la disabilità intellettiva attraverso tre elementi: deficit nelle funzioni intellettive, deficit nel funzionamento adattivo in almeno uno dei tre domini (concettuale, sociale, pratico) ed esordio nel periodo dello sviluppo. La gravità non si basa sul quoziente intellettivo, ma soprattutto sul funzionamento adattivo, cioè su ciò che la persona fa e sa fare nei contesti reali.
ICF in breve
L’ICF propone un modello bio-psico-sociale che integra funzioni e strutture corporee, attività, partecipazione e fattori contestuali (personali e ambientali). Non è una classificazione di malattie, ma una tassonomia del funzionamento umano. Consente di descrivere barriere e facilitatori, orientando la progettazione degli interventi e dei sostegni per migliorare partecipazione e qualità della vita.
AAIDD in breve
L’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities definisce la disabilità intellettiva come una disabilità caratterizzata da significative limitazioni nel funzionamento intellettivo e nel comportamento adattivo, espressa in abilità concettuali, sociali e pratiche, con esordio prima dei 18 anni. Centrale è il concetto di sostegno: l’attenzione si sposta dalla “mancanza” alla qualità e intensità dei supporti necessari per raggiungere esiti di vita migliori.
Confronto operativo
Tutti i quadri convergono su alcuni punti: esordio evolutivo, centralità del funzionamento adattivo, lettura multidimensionale e ruolo decisivo del contesto. In chiave educativa e scolastica questo significa valutazioni integrate, obiettivi realistici e misurabili, sostegni personalizzati e monitoraggio continuo degli esiti, con un lessico comune che facilita il lavoro di equipe.
DSM-5, domini del funzionamento e livelli di gravità
Criteri DSM-5 in sintesi
Nel DSM-5 la disabilità intellettiva è definita dalla compresenza di tre elementi:
- deficit nelle funzioni intellettive (ragionamento, problem solving, pianificazione, pensiero astratto, giudizio);
- deficit nel funzionamento adattivo, con impatto sull’autonomia personale e sociale;
- esordio nel periodo dello sviluppo.
La gravità non è stabilita dal punteggio di un test, ma dal profilo di funzionamento adattivo osservato nei contesti reali di vita.
I tre domini del funzionamento adattivo
Il funzionamento adattivo è descritto in tre domini tra loro interdipendenti.
- Dominio concettuale: abilità accademiche e cognitive applicate alla quotidianità. Comprende linguaggio e comprensione verbale, lettura e scrittura funzionale, calcolo e gestione del denaro, memoria di lavoro, capacità di organizzare informazioni, di pianificare e di passare dall’astratto al concreto.
- Dominio sociale: competenze relazionali. Riguarda la capacità di comprendere regole e ruoli sociali, di cogliere segnali non verbali, di instaurare e mantenere relazioni, di gestire la conversazione, di riconoscere le intenzioni altrui ed esercitare giudizio sociale.
- Dominio pratico: autonomia personale e gestione degli ambienti di vita. Include cura di sé (igiene, alimentazione, vestizione), gestione della casa e della scuola, uso dei mezzi di trasporto, sicurezza personale, gestione del tempo e delle routine, adempimenti scolastici e responsabilità lavorative.
Livelli di gravità nel DSM-5
La gravità è graduata in base all’intensità dei sostegni necessari nei tre domini. Le descrizioni seguenti orientano la progettazione educativa e riabilitativa.
- Lieve
Dominio concettuale: difficoltà nelle abilità accademiche oltre la scuola primaria; beneficiano di metodologie esplicite, tempi distesi e strumenti compensativi.
Dominio sociale: relazioni possibili e significative; possono emergere ingenuità e minore consapevolezza dei contesti, con bisogno di guida nelle situazioni nuove o complesse.
Dominio pratico: buona autonomia nelle attività quotidiane con addestramento; sostegni mirati per pianificare compiti, rispettare scadenze, gestire denaro e sicurezza. - Moderato
Dominio concettuale: apprendimenti funzionali essenziali (lettura/scrittura e calcolo di base) con didattica fortemente strutturata e ripetuta; l’astrazione risulta limitata.
Dominio sociale: comunicazione comprensibile, ma semplificata; difficoltà a interpretare segnali sociali complessi; necessità di mediazione nell’amicizia e nella gestione dei conflitti.
Dominio pratico: autonomia parziale nelle cure personali; nelle attività domestiche, scolastiche e pre-lavorative serve supervisione regolare e routine ben definite. - Grave
Dominio concettuale: apprendimenti molto essenziali e concreti; forte dipendenza da supporti visivi, modellamento e task analysis.
Dominio sociale: comunicazione prevalentemente semplice, spesso con supporti aumentativi/alternativi; interazioni focalizzate su contesti familiari e prevedibili.
Dominio pratico: necessaria supervisione continua per sicurezza, cura di sé, spostamenti e gestione delle attività quotidiane. - Profondo
Dominio concettuale: funzionamento molto limitato; obiettivi centrati su risposte sensori-motorie e routine di base.
Dominio sociale: interazioni basate soprattutto su canali non verbali e sul rapporto con caregiver conosciuti; forte bisogno di mediazione.
Dominio pratico: sostegno pervasivo e continuativo in tutte le attività della vita quotidiana.
Nota su valutazione e QI
I test cognitivi possono contribuire alla comprensione del profilo, ma non determinano da soli diagnosi e gravità. La valutazione integra osservazioni ecologiche, storia evolutiva e analisi del contesto, con attenzione alle barriere e ai facilitatori presenti a scuola, in famiglia e nella comunità.
Implicazioni educative
Il profilo di gravità guida l’intensità e la qualità dei sostegni: obiettivi funzionali e misurabili, ambienti prevedibili, routine chiare, istruzioni esplicite, strategie visive e compensative, opportunità di pratica in contesti naturali e monitoraggio degli esiti. La progettazione tiene insieme i tre domini, così da promuovere partecipazione, autodeterminazione e sicurezza.
ICD-10/11 – classi di gravità, QI ed “età mentale” (cosa rimane e cosa cambia)
ICD-10: il modello tradizionale
La classificazione ICD-10 descrive la disabilità intellettiva con il termine “ritardo mentale” e la suddivide in quattro livelli di gravità basati soprattutto sul Quoziente Intellettivo (QI): lieve (50–69), moderato (35–49), grave (20–34) e profondo (
ICD-11: un approccio aggiornato
Con l’ICD-11 si passa dal concetto di “ritardo mentale” a quello di “disturbo dello sviluppo intellettivo”. La diagnosi continua a basarsi su deficit nelle funzioni intellettive e nel comportamento adattivo con esordio nell’età evolutiva, ma la gravità non è più stabilita solo dal QI. Viene data maggiore importanza al funzionamento adattivo, alla capacità di apprendimento, alla comunicazione, alle abilità sociali e alla partecipazione. Il QI può ancora essere usato come supporto descrittivo, ma non è l’unico né il principale criterio.
Il superamento del concetto di “età mentale”
Il riferimento all’“età mentale” è stato progressivamente abbandonato perché fuorviante. Dire che una persona adulta con disabilità intellettiva “ha un’età mentale di 6 anni” non restituisce un quadro realistico: la persona può avere alcune abilità paragonabili a quelle di un bambino, ma possiede esperienze, affetti e bisogni propri di un adulto. Tale espressione, se usata in ambito educativo, rischia di infantilizzare e di condizionare negativamente le aspettative di insegnanti e famiglie.
Classi di gravità nell’ICD-11
L’ICD-11 mantiene quattro livelli (lieve, moderato, grave, profondo), ma li descrive sulla base del tipo e dell’intensità dei sostegni necessari. Per esempio, nella forma lieve si evidenziano difficoltà di apprendimento che richiedono supporti scolastici mirati, mentre nelle forme gravi e profonde il sostegno riguarda tutte le aree di vita quotidiana e la supervisione è continua. L’attenzione è quindi spostata dal numero a una descrizione qualitativa e operativa, utile per pianificare interventi educativi e riabilitativi.
Il passaggio da un modello centrato sul QI a uno centrato sul funzionamento adattivo e sui sostegni richiesti segna un cambiamento culturale importante. Per la scuola questo significa non fermarsi alla misura del “quanto” uno studente sa, ma analizzare il “come” apprende, in quali condizioni riesce meglio e quali facilitazioni gli permettono di esprimere le proprie potenzialità.

Disponibile il nuovo volume!
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Appunti pratici per il percorso TFA Sostegno
Il libro raccoglie e rielabora in forma di appunti personali i principali argomenti affrontati durante lo studio del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, fornendo una panoramica chiara e organizzata delle tematiche trattate.
Non si tratta di dispense ufficiali, ma di un supporto pratico allo studio, pensato per chi vuole avere una sintesi ragionata e facilmente consultabile.
L’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) rappresenta un cambiamento di prospettiva radicale. Non si concentra solo sulla malattia o sul deficit, ma descrive come la persona funziona nella vita quotidiana, integrando dimensioni biologiche, psicologiche e sociali. La disabilità non è vista come una caratteristica esclusiva dell’individuo, ma come il risultato dell’interazione tra caratteristiche personali e ambiente.
Le dimensioni dell’ICF
L’ICF organizza l’osservazione in diverse componenti interconnesse:
- Funzioni e strutture corporee: riguardano gli aspetti fisiologici e anatomici (es. memoria, linguaggio, motricità, vista, udito).
- Attività: cosa la persona è in grado di fare in contesti specifici (es. leggere, scrivere, lavarsi, cucinare).
- Partecipazione: il coinvolgimento effettivo nella vita scolastica, lavorativa, familiare e comunitaria.
- Fattori ambientali: tutto ciò che può facilitare o ostacolare la partecipazione, come barriere architettoniche, atteggiamenti sociali, accesso a tecnologie, risorse familiari o economiche.
- Fattori personali: età, genere, storia di vita, motivazioni, che non vengono classificati con codici ma influenzano in modo decisivo il funzionamento.
Barriere e facilitatori
Uno dei contributi più innovativi dell’ICF è la possibilità di individuare non solo le limitazioni, ma anche le risorse che permettono di superarle. Una difficoltà di comunicazione, ad esempio, può diventare meno impattante se l’ambiente offre supporti aumentativi o se le persone intorno adottano strategie inclusive. Al contrario, barriere sociali e pregiudizi possono amplificare una difficoltà anche lieve, limitando la partecipazione.
Il linguaggio dell’ICF
Il modello propone un linguaggio neutro e universale che permette a professionisti diversi (medici, insegnanti, educatori, psicologi, terapisti) di condividere osservazioni e progettazioni. L’uso di codici e descrittori comuni facilita la comunicazione interdisciplinare e rende più trasparente il percorso educativo e riabilitativo.
Applicazioni educative
In ambito scolastico, l’ICF aiuta a guardare lo studente non solo attraverso le sue difficoltà, ma come parte di un sistema più ampio. La valutazione non si limita a “cosa non sa fare”, ma si concentra su ciò che può fare con i giusti sostegni. Questo approccio è alla base della redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) secondo il modello bio-psico-sociale introdotto in Italia dal D.Lgs. 66/2017, che chiede di descrivere funzionamento, attività, partecipazione, barriere e facilitatori per ciascun alunno.
Un cambio di prospettiva
Adottare l’ICF significa abbandonare una logica centrata sul deficit per spostarsi su un’ottica di partecipazione e inclusione. Non è più la persona a essere “inadeguata”, ma è l’ambiente che deve adattarsi e fornire le condizioni per permettere a ciascuno di vivere esperienze significative, apprendere e partecipare attivamente alla comunità.
AAIDD – definizione operativa e i cinque assunti chiave sui sostegni
La definizione dell’AAIDD
L’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) propone una delle definizioni più utilizzate a livello internazionale. Secondo questa prospettiva, la disabilità intellettiva è caratterizzata da significative limitazioni sia nel funzionamento intellettivo sia nel comportamento adattivo, che si esprime nelle abilità concettuali, sociali e pratiche, con esordio prima dei 18 anni.
L’elemento distintivo è l’attenzione posta sui sostegni: la disabilità non è una condizione fissa e immutabile, ma il risultato di un’interazione dinamica tra caratteristiche individuali e qualità dei supporti disponibili. Migliorando i sostegni, migliorano anche le opportunità di partecipazione e di autonomia.
I cinque assunti chiave dell’AAIDD
La definizione dell’AAIDD è accompagnata da cinque principi fondamentali che guidano la valutazione e l’intervento:
- Considerare il contesto
Il funzionamento deve essere sempre valutato all’interno degli ambienti di vita della persona, tenendo conto delle aspettative sociali e culturali. - Valutazione multidimensionale
La disabilità intellettiva si manifesta in più aree: abilità intellettive, comportamento adattivo, salute, partecipazione sociale e contesto. La valutazione deve quindi esplorare tutte queste dimensioni. - Limiti coesistono con punti di forza
Ogni persona possiede risorse e competenze che vanno riconosciute e valorizzate, accanto alle difficoltà. Una progettazione efficace parte sempre dall’individuazione dei punti di forza. - Sostegni individualizzati migliorano il funzionamento
Interventi mirati e personalizzati permettono alla persona di raggiungere livelli di autonomia e partecipazione più elevati, riducendo l’impatto delle limitazioni. - Sostegni come leva per la qualità di vita
La qualità della vita dipende in larga misura dall’adeguatezza e dalla continuità dei sostegni: educativi, terapeutici, familiari, tecnologici e sociali.
Il modello dei sostegni
L’AAIDD propone un sistema per descrivere i sostegni in base a quattro livelli di intensità: intermittente, limitato, estensivo e pervasivo. Questo schema aiuta a progettare interventi calibrati sui bisogni reali della persona, evitando generalizzazioni.
Il modello dell’AAIDD sottolinea che il lavoro dell’insegnante e dei professionisti non è semplicemente “adattare il programma”, ma costruire un ambiente che riduca le barriere e potenzi i facilitatori. In quest’ottica, il successo non si misura soltanto in termini di competenze acquisite, ma anche nella possibilità di vivere relazioni soddisfacenti, partecipare attivamente e sentirsi parte della comunità.
Dai modelli alla scuola – valutazione, PEI, obiettivi e sostegni individualizzati
Dal quadro teorico alla pratica scolastica
Le classificazioni internazionali (DSM-5, ICD-11, ICF, AAIDD) forniscono cornici concettuali utili, ma il loro valore emerge davvero quando vengono tradotte in pratiche educative e scolastiche concrete. In classe, infatti, la disabilità intellettiva non è un’etichetta diagnostica: è un insieme di bisogni e potenzialità che richiedono una risposta pedagogica mirata.
Valutazione globale e condivisa
Il punto di partenza è una valutazione globale che consideri abilità cognitive, funzionamento adattivo, fattori emotivi e relazionali, barriere e facilitatori. Non è un’operazione che riguarda solo il docente di sostegno, ma un processo collegiale che coinvolge l’intero consiglio di classe, la famiglia e gli specialisti sanitari o riabilitativi. La valutazione serve non a “misurare quanto manca”, ma a capire su quali risorse fare leva e quali sostegni attivare.
Il PEI come strumento operativo
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) diventa il documento cardine. Nella sua versione aggiornata, ispirata al modello bio-psico-sociale dell’ICF, il PEI descrive:
- il profilo di funzionamento dell’alunno, con punti di forza e aree di difficoltà;
- le barriere e i facilitatori presenti nell’ambiente scolastico e familiare;
- gli obiettivi educativi e didattici, concreti e misurabili;
- i sostegni, le metodologie e gli strumenti compensativi da adottare;
- le modalità di verifica e valutazione dei progressi.
Obiettivi realistici e significativi
Gli obiettivi devono essere tarati sul livello di funzionamento e avere un significato funzionale nella vita dello studente. Ad esempio, non si tratta solo di “imparare a leggere un testo narrativo”, ma di acquisire la capacità di comprendere messaggi scritti utili nella vita quotidiana (cartelli, istruzioni, comunicazioni scolastiche). In questo senso la didattica speciale non riduce, ma rende gli apprendimenti più vicini alle necessità reali.
Sostegni personalizzati
I sostegni non si limitano all’aiuto diretto dell’insegnante di sostegno, ma comprendono:
- strategie didattiche inclusive (uso di immagini, schemi, semplificazione linguistica, ripetizioni guidate);
- strumenti tecnologici (software di scrittura semplificata, comunicazione aumentativa, applicazioni per la gestione delle routine);
- organizzazione ambientale (routine prevedibili, spazi ordinati, tempi distesi);
- supporti sociali (gruppi di pari, tutoring, cooperative learning).
Collaborazione e corresponsabilità
La riuscita del percorso dipende dalla corresponsabilità: tutti i docenti devono sentirsi coinvolti, la famiglia deve essere parte attiva e i professionisti esterni devono condividere le strategie. Solo così si crea un ambiente coerente e facilitante che sostiene lo sviluppo globale dello studente.
La prospettiva di lungo termine
La scuola non prepara solo a superare verifiche, ma a costruire competenze utili per il futuro: autonomia, capacità di scelta, relazioni sociali, orientamento al lavoro. Ogni obiettivo scolastico deve essere visto come un tassello di un progetto di vita più ampio, che accompagna lo studente anche oltre l’esperienza scolastica.
Sintesi finale – cosa tenere a mente nella pratica didattica
Integrare i modelli, non contrapporli
DSM-5, ICD-11, ICF e AAIDD offrono prospettive diverse ma complementari. Insieme consentono di leggere la disabilità intellettiva non come un’etichetta statica, ma come una condizione complessa che richiede uno sguardo multidimensionale. Nella pratica scolastica questo significa saper integrare criteri clinici, osservazioni sul funzionamento adattivo, descrizioni delle abilità e analisi dei contesti.
Dal deficit alla partecipazione
La disabilità intellettiva non è definita solo da ciò che manca, ma soprattutto da ciò che può essere costruito attraverso i sostegni. L’attenzione non deve essere centrata sul punteggio di un test, ma sulla possibilità di garantire partecipazione, inclusione e qualità della vita.
Il ruolo dell’insegnante
Ogni insegnante, e non solo il docente di sostegno, ha un ruolo cruciale. L’inclusione non è una delega, ma un compito condiviso che richiede progettazione comune, strategie didattiche inclusive e un clima relazionale positivo. La relazione educativa, l’empatia e la capacità di valorizzare i punti di forza sono strumenti tanto importanti quanto le metodologie didattiche.
Centralità dei sostegni
I modelli più recenti, come quello dell’AAIDD e dell’ICF, hanno evidenziato che i sostegni non sono un “aggiustamento” secondario, ma la leva principale per favorire lo sviluppo. Sostegni mirati, calibrati e continuativi possono trasformare in modo significativo il livello di autonomia e di partecipazione di uno studente.
Progettazione orientata al futuro
Ogni scelta didattica dovrebbe guardare oltre l’immediato, in una prospettiva di progetto di vita. L’obiettivo non è solo apprendere contenuti scolastici, ma formare persone capaci di vivere esperienze significative, instaurare relazioni, orientarsi nel lavoro e nella comunità, sentirsi parte attiva della società.
Una sintesi operativa per la scuola
- Valutare la persona nella sua globalità, integrando dimensioni cognitive, adattive, emotive e contestuali.
- Elaborare obiettivi chiari, concreti e funzionali, inseriti nel PEI.
- Offrire sostegni personalizzati, dalle tecnologie alle metodologie didattiche inclusive.
- Favorire la corresponsabilità di docenti, famiglia e specialisti, per un progetto educativo condiviso.
- Coltivare sempre uno sguardo orientato alla partecipazione e all’inclusione, superando una visione centrata sul deficit.
Conclusione
La disabilità intellettiva, lungi dall’essere una condizione fissa e limitante, è un ambito in cui scuola, famiglia e comunità possono fare una differenza concreta. Con il giusto equilibrio tra conoscenze teoriche e sensibilità educativa, l’insegnante diventa il facilitatore di un percorso che non solo sviluppa competenze, ma costruisce possibilità di vita autentica e dignitosa per ogni studente.
Disclaimer: I contenuti hanno carattere divulgativo e non sostituiscono materiale didattico ufficiale. Sono pensati come risorsa di supporto per lo studio e la preparazione a percorsi formativi e concorsuali.
👉 Entra nel gruppo