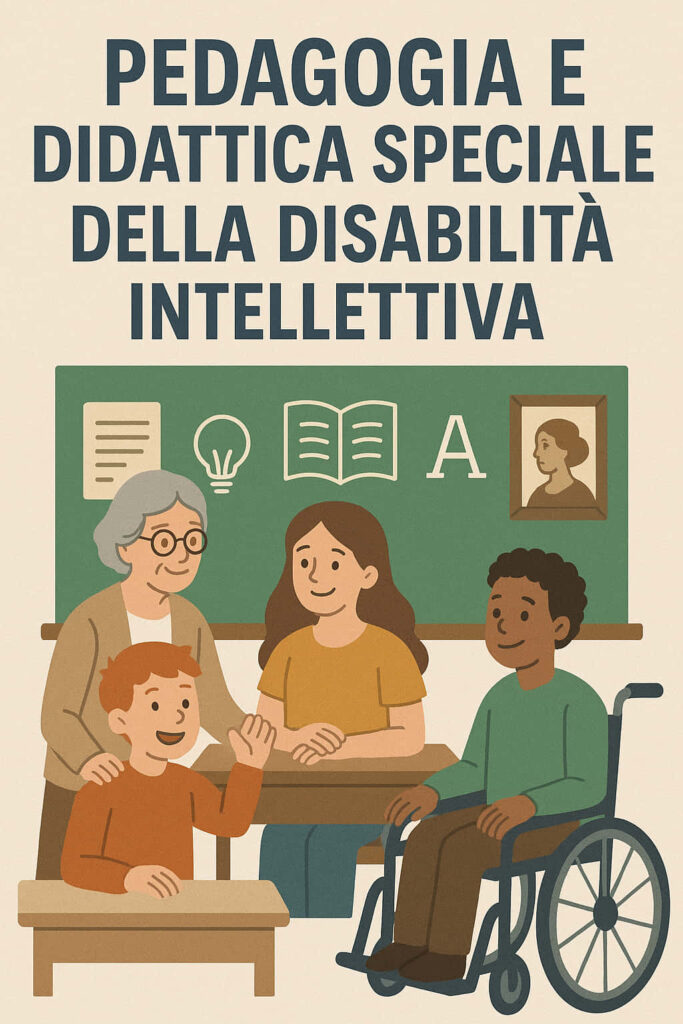Quadro di riferimento: DSM, ICD, ICF, Profilo di Funzionamento, PEI e PDP
Per comprendere come la scuola possa rispondere ai bisogni educativi degli alunni con disturbi del neurosviluppo è fondamentale conoscere i principali strumenti diagnostici e i documenti che guidano la progettazione educativa. Questi elementi formano una sorta di “mappa” che collega il mondo clinico con quello scolastico, permettendo agli insegnanti di orientarsi tra certificazioni, valutazioni e piani didattici personalizzati.
DSM – Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali
Il DSM, elaborato dall’American Psychiatric Association, raccoglie e descrive i disturbi mentali sulla base di criteri clinici specifici. È uno strumento utilizzato soprattutto in ambito sanitario e di ricerca, utile a stabilire diagnosi uniformi e condivise. Pur non essendo un documento scolastico, ha una ricaduta indiretta sull’attività didattica, poiché definisce il quadro clinico da cui prendono avvio le decisioni educative e gli interventi personalizzati.
ICD – Classificazione Internazionale delle Malattie
L’ICD, redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, classifica le malattie e i disturbi in modo sistematico. Oltre a finalità cliniche e statistiche, rappresenta lo strumento ufficiale di riferimento per la certificazione sanitaria. Anche in questo caso il suo ruolo nella scuola è indiretto: fornisce la base diagnostica da cui derivano le certificazioni e le procedure che attivano i percorsi inclusivi.
ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
A differenza di DSM e ICD, l’ICF non si concentra sulla malattia, ma sul funzionamento globale della persona. Valuta come le condizioni di salute interagiscono con l’ambiente e con le attività quotidiane. È particolarmente importante in ambito scolastico perché consente di cogliere non solo le difficoltà, ma anche le risorse e i fattori facilitanti dell’alunno, diventando la lente attraverso cui leggere bisogni educativi e progettare interventi mirati.
Profilo di Funzionamento
Il Profilo di Funzionamento è il documento che traduce concretamente la logica dell’ICF in una descrizione personalizzata dello studente. Redatto dai servizi sanitari in collaborazione con la famiglia e la scuola, offre una visione complessiva di abilità, limitazioni e contesto di vita. Costituisce la base di partenza per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, collegando quindi il mondo clinico con quello didattico.
PEI – Piano Educativo Individualizzato
Il PEI rappresenta il cuore della progettazione inclusiva. È elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che riunisce docenti, famiglia e operatori sanitari. Questo documento traduce le informazioni del Profilo di Funzionamento in obiettivi educativi e didattici concreti, stabilendo strategie di insegnamento, strumenti, modalità di verifica e criteri di valutazione. Il suo scopo è garantire un percorso scolastico realmente accessibile e significativo, favorendo l’inclusione dell’alunno in tutte le dimensioni della vita di classe.
PDP – Piano Didattico Personalizzato
Il PDP viene redatto dal consiglio di classe per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o altri Bisogni Educativi Speciali. Viene predisposto generalmente entro il primo trimestre, dopo un periodo di osservazione, e definisce strumenti compensativi, misure dispensative, metodologie personalizzate e modalità di verifica. È un documento flessibile, aggiornabile nel corso dell’anno, che funge da guida operativa per docenti e studenti con l’obiettivo di favorire pari opportunità di apprendimento.
Disturbi Specifici dell’Apprendimento a scuola
Definizione e caratteristiche
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) comprendono dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Si tratta di difficoltà circoscritte a specifici ambiti dell’apprendimento scolastico, che non dipendono da deficit cognitivi, mancanza di opportunità educative o problemi sensoriali. Gli studenti con DSA presentano capacità cognitive nella norma, ma incontrano ostacoli significativi e persistenti nell’acquisizione automatica di lettura, scrittura o calcolo.
Un aspetto centrale è la resistenza all’automatizzazione: il bambino o il ragazzo impiega molte più energie rispetto ai coetanei per leggere, scrivere o svolgere operazioni matematiche. Questo provoca affaticamento, rallentamento e, in molti casi, frustrazione, con possibili ripercussioni emotive e motivazionali.
Valutazione e diagnosi
La diagnosi di DSA è di competenza dei servizi sanitari (neuropsichiatria infantile o centri autorizzati), che utilizzano test standardizzati. La certificazione consente l’attivazione di un percorso personalizzato in ambito scolastico. È importante che la scuola, già prima della diagnosi formale, osservi e segnali eventuali difficoltà persistenti, così da avviare interventi tempestivi e mirati.
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Il PDP è lo strumento principale per la presa in carico scolastica degli studenti con DSA. È predisposto dal consiglio di classe entro il primo trimestre, dopo un’attenta osservazione, e viene aggiornato nel corso dell’anno. Il documento contiene:
- profilo dell’alunno, con descrizione dei punti di forza e delle aree di difficoltà;
- strategie didattiche personalizzate, mirate a favorire l’apprendimento;
- strumenti compensativi, cioè strumenti che riducono il carico di difficoltà (ad esempio sintesi vocale, calcolatrice, mappe concettuali, tabelle, software specifici);
- misure dispensative, ossia adattamenti che alleggeriscono le richieste scolastiche senza penalizzare l’apprendimento (ad esempio tempi più lunghi nelle prove, riduzione del numero di esercizi, esonero dalla lettura ad alta voce);
- modalità di verifica e valutazione, calibrate sulle caratteristiche dell’alunno per garantire equità e non penalizzare la difficoltà specifica.
Strategie didattiche efficaci
Gli insegnanti possono adottare diverse strategie per rendere l’apprendimento più accessibile:
- presentare le informazioni in più modalità (visiva, uditiva, pratica);
- utilizzare mappe concettuali e schemi per facilitare l’organizzazione dei contenuti;
- ridurre la quantità di materiale scritto e privilegiare la comprensione dei concetti;
- incoraggiare l’uso di strumenti digitali e tecnologici;
- prevedere verifiche orali in alternativa a quelle scritte, quando opportuno.
Un principio fondamentale è lavorare sulle competenze e sugli interessi dello studente, per valorizzarne le potenzialità e motivarlo a superare le difficoltà.
Un caso pratico e gli obiettivi SMART
Immaginiamo un alunno di seconda media con diagnosi di dislessia e discalculia. Presenta una lettura lenta e faticosa e difficoltà nel memorizzare le tabelline, ma mostra buone competenze orali e grande interesse per la tecnologia.
Il consiglio di classe, nel PDP, stabilisce obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Accessibili, Realistici, Temporizzati), ad esempio:
- Migliorare la comprensione dei testi attraverso l’uso della sintesi vocale, con valutazione periodica dei progressi ogni due mesi.
- Potenziare il calcolo scritto con strategie di scomposizione e utilizzo della calcolatrice, monitorando i miglioramenti tramite verifiche programmate.
- Favorire l’autonomia nello studio introducendo mappe concettuali digitali, con obiettivo di utilizzarle in almeno tre discipline entro la fine del quadrimestre.
Grazie a questo approccio, lo studente non viene definito dal disturbo, ma sostenuto nel percorso scolastico in modo personalizzato e orientato al successo formativo.
ADHD a scuola: comprendere e gestire il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività
Caratteristiche principali
L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo del neurosviluppo che si manifesta con difficoltà di attenzione, impulsività e iperattività motoria. Gli studenti con ADHD possono avere problemi a mantenere la concentrazione su compiti prolungati, a rispettare le regole della classe e a controllare le proprie reazioni.
Le manifestazioni variano molto da studente a studente. Alcuni presentano prevalentemente disattenzione (ad esempio si distraggono facilmente o non portano a termine i compiti), altri mostrano soprattutto iperattività e impulsività (si muovono continuamente, parlano troppo, interrompono gli altri). Spesso è presente una combinazione dei due aspetti.
È importante sottolineare che l’ADHD non è una scelta né una cattiva educazione, ma un disturbo neurobiologico che coinvolge il funzionamento dell’attenzione e dell’autoregolazione.
Le difficoltà a scuola
In classe, un alunno con ADHD può apparire irrequieto, avere difficoltà a rispettare i tempi di lavoro, dimenticare facilmente materiali scolastici e istruzioni. Questo può portare a frustrazione, calo dell’autostima e conflitti con compagni e insegnanti.
Un esempio tipico è lo studente che si alza continuamente dal banco, disturba la lezione con interventi fuori luogo o fatica a completare i compiti scritti. Senza adeguati supporti, rischia di accumulare insuccessi scolastici e di sviluppare una visione negativa di sé come “incapace” o “problematico”.
Strategie didattiche e adattamenti
Per favorire l’apprendimento e la partecipazione degli studenti con ADHD è utile adottare alcune strategie:
- Strutturare la lezione in segmenti brevi, alternando attività diverse e pause brevi.
- Stabilire regole chiare e condivise, con richiami visivi (poster, schede) e rinforzi positivi.
- Predisporre un ambiente facilitante, ad esempio posizionando l’alunno vicino all’insegnante per ridurre le distrazioni.
- Utilizzare supporti visivi e organizzativi, come checklist, agende o timer, per aiutare la gestione del tempo e delle attività.
- Favorire la partecipazione attiva, assegnando piccoli compiti di responsabilità (consegna di materiali, gestione di strumenti), così da canalizzare l’energia in modo costruttivo.
Le misure dispensative e compensative possono includere la riduzione del carico di lavoro scritto, tempi più lunghi per le verifiche e l’utilizzo di strumenti digitali.
Relazione scuola-famiglia
La collaborazione tra insegnanti e famiglia è fondamentale. I genitori possono fornire informazioni preziose sulle modalità con cui il bambino affronta le difficoltà a casa, mentre la scuola può condividere osservazioni e progressi. Un dialogo costante consente di adottare strategie coerenti e di rinforzare i comportamenti positivi.
Un esempio pratico: se a casa i genitori utilizzano un sistema di premi per i compiti completati, è utile che anche la scuola adotti modalità simili di rinforzo positivo, creando continuità tra i due ambienti di vita.
Obiettivi educativi
Gli interventi a scuola non hanno come obiettivo eliminare l’ADHD, ma aiutare lo studente a sviluppare strategie di autoregolazione, potenziare l’autonomia e valorizzare le sue capacità. In questo senso, la personalizzazione didattica e il clima di classe inclusivo giocano un ruolo centrale.
Disturbi dello Spettro Autistico a scuola
Caratteristiche principali
I Disturbi dello Spettro Autistico (DSA, da non confondere con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento) comprendono un insieme eterogeneo di condizioni che si manifestano con difficoltà nella comunicazione sociale e la presenza di interessi o comportamenti ristretti e ripetitivi. L’espressione “spettro” sottolinea l’ampia variabilità: alcuni bambini presentano compromissioni gravi che richiedono supporto costante, altri hanno un funzionamento intellettivo nella norma o superiore, ma incontrano difficoltà nell’interazione sociale e nella flessibilità comportamentale.
In ambito scolastico questo significa trovarsi di fronte a studenti con bisogni molto diversi: c’è chi necessita di un intervento intensivo e altamente strutturato e chi, invece, ha bisogno soprattutto di un supporto nelle relazioni con i compagni e nell’adattamento alle regole implicite della classe.
Le difficoltà più comuni a scuola
Le principali aree di difficoltà riguardano:
- Comunicazione: lo studente può avere linguaggio assente, limitato o particolare (ecolalie, uso letterale del linguaggio, difficoltà a comprendere ironia e metafore).
- Relazioni sociali: può faticare a condividere interessi, a partecipare a giochi di gruppo, a interpretare espressioni facciali e gesti.
- Comportamenti ripetitivi: tendenza a rituali, routine rigide, interessi ristretti o movimenti stereotipati.
- Sensibilità sensoriale: ipersensibilità a suoni, luci, odori o, al contrario, ricerca di stimoli intensi.
Un esempio frequente è lo studente che reagisce con disagio a un cambiamento improvviso nell’orario o che mostra forte interesse esclusivo per un argomento, parlandone in modo ripetitivo.
Approccio educativo
L’inclusione di un alunno con autismo richiede un approccio individualizzato, strutturato e coerente. Alcuni principi chiave sono:
- Strutturare l’ambiente e il tempo: routine prevedibili, orari visivi, sequenze illustrate di attività.
- Utilizzare la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA): simboli, immagini, gesti o tecnologie digitali per supportare la comunicazione.
- Promuovere abilità sociali: attraverso attività guidate, giochi di ruolo, tutoring tra pari.
- Valorizzare interessi specifici: trasformarli in risorsa per motivare e favorire l’apprendimento.
- Adattare i compiti: proporre consegne chiare, semplici e spezzate in passaggi brevi.
Strumenti operativi
Gli insegnanti possono utilizzare schede visive, agende illustrate, social stories (brevi racconti che spiegano situazioni sociali), oltre a software e applicazioni per la comunicazione. È utile creare spazi tranquilli in classe in cui lo studente possa regolare le proprie emozioni nei momenti di sovraccarico.
Inclusione e clima di classe
L’obiettivo non è solo il supporto individuale, ma anche la costruzione di un contesto inclusivo. I compagni vanno sensibilizzati al rispetto delle differenze e guidati a interagire in modo positivo con lo studente con autismo. Attività cooperative, lavori di gruppo strutturati e momenti di condivisione favoriscono la partecipazione e riducono l’isolamento.
Un esempio concreto: se uno studente con autismo mostra interesse particolare per i treni, si può proporre un progetto di classe sul tema dei trasporti, dove ognuno contribuisce con un compito diverso. In questo modo l’interesse individuale diventa motore di inclusione e apprendimento collettivo.
Disabilità intellettive a scuola
Caratteristiche principali
La disabilità intellettiva si caratterizza per un funzionamento cognitivo significativamente al di sotto della media, accompagnato da difficoltà nell’adattamento alla vita quotidiana. Non riguarda solo le capacità intellettive in senso stretto (attenzione, memoria, linguaggio, ragionamento), ma anche le competenze sociali e pratiche necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni.
L’espressione e la gravità della disabilità intellettiva sono molto variabili. Alcuni studenti necessitano di un supporto costante e intensivo, mentre altri possono sviluppare una buona autonomia nelle attività quotidiane con interventi educativi mirati.
Valutazione e contesto scolastico
In ambito scolastico, la valutazione non si concentra soltanto sul livello cognitivo, ma soprattutto sulle abilità adattive e sulla partecipazione. È importante osservare come lo studente affronta le richieste quotidiane della classe, come comunica, come si relaziona con i compagni e quali strategie utilizza per risolvere piccoli problemi.
Il Profilo di Funzionamento e il PEI permettono di raccogliere queste informazioni e di trasformarle in obiettivi concreti, realistici e misurabili. L’accento non è posto sul deficit, ma sulle possibilità di sviluppo e sulla costruzione di percorsi personalizzati.
Strategie di insegnamento
Gli studenti con disabilità intellettiva apprendono meglio attraverso metodologie attive e concrete. Alcuni principi utili sono:
- Spezzare i compiti in passaggi semplici e chiari, fornendo esempi concreti.
- Usare supporti visivi e pratici, come immagini, oggetti reali, schede illustrate.
- Ripetere e rinforzare le informazioni per favorire la memorizzazione.
- Favorire l’apprendimento esperienziale, attraverso laboratori, attività manuali, giochi educativi.
- Valorizzare la comunicazione multimodale, anche con l’uso di strumenti digitali o CAA.
È fondamentale adottare una didattica flessibile, che tenga conto dei tempi e dei ritmi individuali, evitando confronti penalizzanti con i coetanei.
Inclusione nella classe
L’inserimento scolastico degli studenti con disabilità intellettiva ha come obiettivo non solo l’apprendimento, ma soprattutto la partecipazione sociale. Le attività cooperative, il tutoring tra pari e i progetti inclusivi di classe favoriscono la costruzione di relazioni positive.
Un esempio efficace è il “circle time”, momento in cui tutti gli alunni condividono esperienze e riflessioni: questo consente anche allo studente con disabilità intellettiva di sentirsi parte attiva del gruppo.
Obiettivi educativi
Gli obiettivi per studenti con disabilità intellettiva non riguardano soltanto le competenze scolastiche, ma anche:
- lo sviluppo dell’autonomia personale (gestione del materiale, spostamenti, cura di sé);
- le abilità sociali (collaborare, rispettare regole, comunicare bisogni e opinioni);
- la preparazione alla vita adulta (competenze pratiche, orientamento al lavoro).
In questa prospettiva, la scuola diventa un contesto di crescita globale, dove l’apprendimento scolastico si intreccia con lo sviluppo di competenze utili per il futuro.
Disturbi del linguaggio a scuola
Caratteristiche principali
I disturbi del linguaggio si manifestano con difficoltà nella comprensione e/o nella produzione del linguaggio parlato. Possono riguardare diversi aspetti: fonologia (i suoni), morfosintassi (la costruzione delle frasi), semantica (il significato delle parole) e pragmatica (l’uso del linguaggio in contesti sociali).
Questi disturbi non sono dovuti a deficit cognitivi generali, ma a difficoltà specifiche nello sviluppo linguistico. Possono presentarsi in forma più lieve, con ritardi nel parlare, oppure in maniera più complessa, con compromissioni che influenzano fortemente la comunicazione quotidiana.
Tipologie di disturbi del linguaggio
Tra i più comuni si trovano:
- Disturbo fonologico: difficoltà a produrre correttamente alcuni suoni, con errori che compromettono l’intelligibilità del linguaggio.
- Disturbo del linguaggio espressivo: difficoltà a trovare le parole giuste o a costruire frasi corrette.
- Disturbo della comprensione: difficoltà a comprendere le parole e le frasi, con conseguenti problemi nell’interazione e nello studio.
- Disturbo misto recettivo-espressivo: coinvolge sia la comprensione sia l’espressione.
Difficoltà scolastiche
Gli studenti con disturbi del linguaggio possono incontrare ostacoli nella lettura, nella scrittura, nell’acquisizione del lessico e nello studio delle discipline. Le difficoltà comunicative possono anche ripercuotersi sulla socializzazione, con rischio di isolamento o frustrazione.
Un esempio tipico è il bambino che, pur avendo buone capacità cognitive, fatica a raccontare una storia in modo chiaro, a comprendere un testo letto ad alta voce o a seguire spiegazioni complesse.
Strumenti e strategie didattiche
La scuola può giocare un ruolo decisivo nel supporto agli studenti con disturbi del linguaggio. Alcune strategie utili sono:
- Parlare in modo chiaro e scandito, evitando frasi troppo lunghe o complesse.
- Accompagnare la spiegazione con supporti visivi (immagini, schemi, mappe concettuali).
- Favorire l’uso di strumenti digitali, come software di sintesi vocale o programmi di supporto linguistico.
- Sostenere la comunicazione multimodale, includendo gesti, immagini, simboli.
- Dare più tempo per rispondere a domande o svolgere compiti.
Inclusione e partecipazione
Gli insegnanti possono promuovere attività di gruppo che stimolino la comunicazione, valorizzando i progressi e riducendo l’ansia da prestazione. È importante creare un clima di classe accogliente, dove gli errori linguistici non vengano derisi, ma affrontati con naturalezza.
Un esempio pratico: durante la lettura condivisa, lo studente con disturbo del linguaggio può avere un ruolo attivo evidenziando le immagini, ponendo domande o raccontando brevi parti della storia con l’aiuto dell’insegnante.
Obiettivi educativi
Gli obiettivi non si limitano al potenziamento linguistico, ma comprendono anche lo sviluppo della fiducia in sé, la capacità di comunicare in diversi contesti e la partecipazione alle attività della classe. Lavorare sulle competenze comunicative, anche con piccoli progressi, significa aprire la strada a un apprendimento più sicuro e a relazioni sociali più ricche.
Disturbi motori a scuola
Caratteristiche principali
I disturbi motori comprendono un ampio ventaglio di condizioni che influenzano la capacità di movimento, la coordinazione e l’autonomia. Possono derivare da cause congenite, genetiche, acquisite o da lesioni neurologiche, e si manifestano con livelli molto variabili di gravità. Alcuni studenti hanno difficoltà lievi di motricità fine (ad esempio scrivere o manipolare piccoli oggetti), mentre altri presentano limitazioni significative della motricità grossolana, che incidono sulla deambulazione e sulla postura.
La disabilità motoria non riguarda solo la dimensione fisica, ma può avere effetti anche sull’apprendimento, sulla partecipazione e sulle relazioni, soprattutto quando non sono presenti adeguati supporti e adattamenti.
Tipologie di disturbi motori
Tra i più comuni troviamo:
- Paralisi cerebrale infantile: compromissione motoria causata da danni cerebrali precoci, con manifestazioni molto diverse (spasticità, movimenti involontari, problemi di equilibrio).
- Distrofie muscolari: malattie genetiche che comportano progressiva debolezza muscolare.
- Malformazioni congenite o esiti di traumi: che incidono sulla mobilità o sull’uso degli arti.
- Disturbi della coordinazione motoria: difficoltà meno gravi ma che rendono complessi alcuni compiti quotidiani.
Impatto sulle attività scolastiche
Le difficoltà motorie possono influenzare diversi aspetti della vita scolastica:
- Spostamenti: entrare e muoversi negli ambienti scolastici può essere complesso senza barriere architettoniche abbattute.
- Attività manuali: scrivere, disegnare, ritagliare o utilizzare strumenti richiede tempi più lunghi o strumenti adattati.
- Partecipazione: lo studente può sentirsi escluso da giochi, attività sportive o laboratoriali.
Un esempio pratico: un bambino con difficoltà motorie agli arti superiori può faticare a prendere appunti velocemente, rischiando di perdere parte della spiegazione.
Strategie didattiche e strumenti
Per favorire l’inclusione degli studenti con disturbi motori è utile:
- garantire accessibilità agli spazi (aule, bagni, laboratori, palestra);
- predisporre strumenti compensativi (tastiere adattate, software di videoscrittura, ausili per la presa della penna);
- concedere tempi aggiuntivi per compiti e verifiche;
- proporre attività alternative in educazione fisica, che consentano la partecipazione attiva senza rischi o frustrazioni;
- incoraggiare la collaborazione tra pari, ad esempio con lavori di gruppo in cui ciascuno contribuisce secondo le proprie possibilità.
Oltre agli aspetti pratici, è fondamentale lavorare sul clima della classe. Gli studenti con disabilità motoria non devono essere percepiti come “esonerati” dalle attività, ma come parte attiva del gruppo, con compiti e responsabilità adeguati alle loro capacità.
Un esempio inclusivo: durante un’attività sportiva di squadra, lo studente con difficoltà motorie può assumere il ruolo di arbitro, cronometrista o gestore dei punteggi, contribuendo al gioco in modo significativo.
Obiettivi educativi
Gli obiettivi non si limitano al potenziamento delle abilità residue, ma comprendono anche:
- lo sviluppo dell’autonomia personale;
- l’incremento della partecipazione sociale;
- il potenziamento dell’autostima e delle relazioni positive con i compagni.
In questa prospettiva, la scuola diventa uno spazio di crescita in cui l’accessibilità fisica si intreccia con l’accessibilità sociale, rendendo possibile una vera inclusione.

Disponibile il nuovo volume!
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Appunti pratici per il percorso TFA Sostegno
Il libro raccoglie e rielabora in forma di appunti personali i principali argomenti affrontati durante lo studio del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, fornendo una panoramica chiara e organizzata delle tematiche trattate.
Non si tratta di dispense ufficiali, ma di un supporto pratico allo studio, pensato per chi vuole avere una sintesi ragionata e facilmente consultabile.
Disturbi sensoriali a scuola
Caratteristiche principali
I disturbi sensoriali comprendono deficit della vista e dell’udito che incidono in modo significativo sull’apprendimento e sulla partecipazione scolastica. La gravità può variare da forme lievi, compensabili con ausili, fino a situazioni di cecità totale o sordità profonda.
Questi disturbi non compromettono necessariamente le capacità cognitive, ma rendono più complesso l’accesso alle informazioni e la comunicazione. Per questo motivo la scuola deve predisporre adattamenti e strategie inclusive che permettano a ciascun alunno di apprendere e partecipare pienamente alla vita della classe.
Disturbi della vista
Cecità
Gli studenti ciechi necessitano di strumenti specifici per l’accesso ai contenuti: scrittura e lettura in Braille, sintesi vocali, software screen reader, mappe tattili. L’autonomia negli spostamenti può essere favorita da percorsi tattili e da spazi organizzati in modo stabile e sicuro.
Ipovisione
Chi ha una riduzione parziale della vista può beneficiare di strumenti come lenti di ingrandimento, schermi elettronici, testi a caratteri ingranditi, software di ingrandimento e illuminazione adeguata in classe. Anche piccoli accorgimenti, come posizionare l’alunno vicino alla lavagna o utilizzare materiali ad alto contrasto, possono fare la differenza.
Disturbi dell’udito
Sordità
Gli studenti sordi possono utilizzare la Lingua dei Segni Italiana (LIS), la lettura labiale o impianti cocleari. In classe è fondamentale assicurare una comunicazione chiara, mediata da interpreti LIS se necessario, e favorire l’uso di tecnologie assistive come microfoni a radiofrequenza.
Ipoacusia
In caso di riduzione parziale dell’udito, possono bastare apparecchi acustici e ambienti scolastici acusticamente favorevoli. È importante parlare rivolgendosi allo studente, articolando bene e riducendo i rumori di fondo.
Strategie didattiche comuni
Per entrambi i tipi di disturbi sensoriali la scuola può adottare strategie trasversali:
- Personalizzare i materiali: testi in Braille, in formato digitale, audiolezioni, sottotitoli.
- Utilizzare più canali comunicativi: visivo, uditivo, tattile.
- Creare ambienti accessibili: illuminazione adeguata, riduzione del rumore, organizzazione degli spazi.
- Favorire la collaborazione tra pari, promuovendo attività di gruppo che stimolino la cooperazione e la condivisione.
Inclusione e partecipazione
L’obiettivo non è solo fornire strumenti compensativi, ma costruire un contesto realmente inclusivo. Gli studenti con disturbi sensoriali devono poter partecipare alle attività di classe non come spettatori, ma come protagonisti.
Un esempio: durante una lezione di scienze, lo studente cieco può esplorare modelli tattili o plastici, mentre lo studente sordo può seguire tramite sottotitoli o con il supporto di un interprete LIS. In entrambi i casi, la classe intera impara a valorizzare le diverse modalità di apprendimento.
Conclusioni e riflessioni sull’inclusione scolastica
Un percorso complesso ma necessario
L’inclusione scolastica degli alunni con disturbi del neurosviluppo, disabilità intellettive, disturbi del linguaggio, motori e sensoriali rappresenta una sfida quotidiana per insegnanti, famiglie e istituzioni. È un percorso complesso perché richiede la capacità di leggere i bisogni specifici di ciascun alunno, di personalizzare i percorsi educativi e di predisporre strategie didattiche flessibili. Allo stesso tempo, è un obiettivo imprescindibile: la scuola inclusiva non è solo un diritto sancito dalle normative, ma una condizione essenziale per la crescita sociale e culturale di tutti.
Il ruolo degli insegnanti e della comunità scolastica
Gli insegnanti hanno un ruolo centrale: sono chiamati a essere osservatori attenti, mediatori culturali, facilitatori dell’apprendimento e promotori di relazioni positive. Non sono però soli: l’inclusione è il risultato di una rete che coinvolge famiglie, specialisti sanitari, enti locali e naturalmente i compagni di classe. Solo attraverso la collaborazione di tutti è possibile costruire un ambiente realmente accogliente.
La classe diventa così un microcosmo di società, dove le differenze non vengono viste come ostacoli, ma come opportunità di crescita reciproca. Ogni studente impara che il successo non si misura solo nei voti, ma anche nella capacità di valorizzare i talenti propri e altrui.
Dal documento all’esperienza vissuta
PEI, PDP, profili di funzionamento e altri strumenti operativi sono fondamentali per orientare l’azione educativa. Tuttavia, la vera sfida è tradurre questi documenti in pratiche quotidiane, coerenti e significative. Un piano scritto non ha valore se non si trasforma in esperienza vissuta in classe, in attività che motivano, sostengono e responsabilizzano lo studente.
Verso una scuola inclusiva
L’inclusione non si limita a “fare spazio” agli studenti con bisogni educativi speciali, ma implica una trasformazione dell’intero sistema scolastico. Una scuola inclusiva è una scuola che sa differenziare l’insegnamento, che valorizza le potenzialità di ciascuno, che costruisce relazioni e che prepara i cittadini del futuro a vivere in una società pluralista e rispettosa delle diversità.
In questo senso, l’inclusione non è un traguardo da raggiungere una volta per tutte, ma un processo continuo di adattamento, riflessione e miglioramento. È un cammino che richiede impegno, creatività e consapevolezza, ma che porta con sé il risultato più importante: la possibilità, per ogni studente, di sentirsi parte della comunità scolastica e di crescere come persona.
Disclaimer: I contenuti hanno carattere divulgativo e non sostituiscono materiale didattico ufficiale. Sono pensati come risorsa di supporto per lo studio e la preparazione a percorsi formativi e concorsuali.
👉 Entra nel gruppo